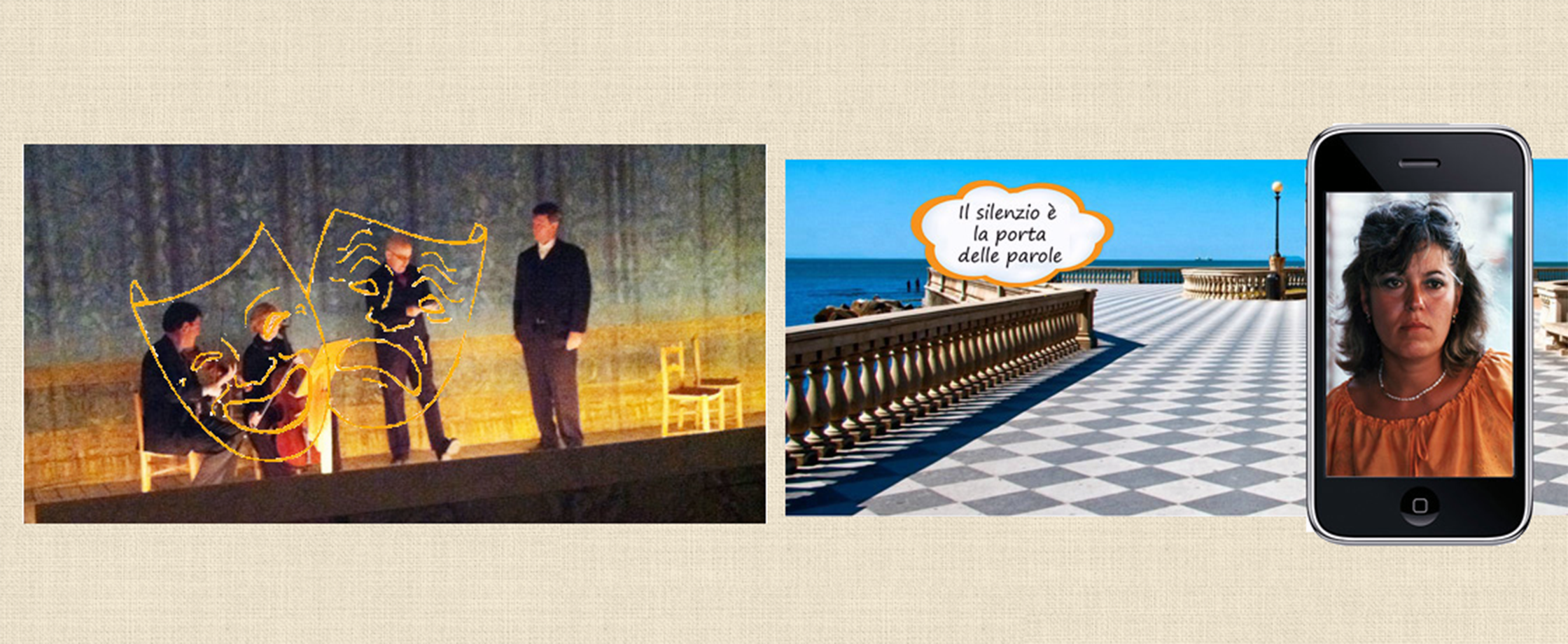
TE LA RICORDI LA NANA?
Al mondo non c'è proprietario di cane che non abbia mirabilia da raccontare sul proprio amico a quattro zampe.
Io non so se la Nana fosse così degna di considerazione, ma se, quando capito nel quartiere dove sono cresciuta, le persone che incontro, dopo i convenevoli di rito, mi chiedono: «Te la ricordi la Nana?» e se la mia maestra, ormai novantenne, ma con la memoria ancora sveglia, mi dice: «Te li ricordi i temi sulla Nana?» vuol dire che qualcosa di speciale la Nana l'aveva.
La razza? Come diciamo dalle mie parti, “un incrocio tra un ciuco e un barroccio”; insomma, il frutto di chissà quante generazioni di meticci. Era comunque di taglia piuttosto piccola, dal pelo lungo e chiazzato, con un musetto che ricordava vagamente un volpino, le orecchie a punta, la coda ingombrante e il nasino bicolore.
Babbo la comprò quando mamma era incinta, per mille lire, e per portarla a casa, se la mise nella tasca del giaccone di pelle: era novembre e quel cosino appena nato tremava di paura e di freddo. La portarono nel loro letto, le prime notti, perché i guaiti disperati, nella solitudine della cucina, non facevano dormire nessuno.
Mamma fu il suo primo e unico vero amore: l'adorava e la seguiva quasi dappertutto, solo da lei si faceva fare il bagno e pettinare nei periodi in cui perdeva il pelo lungo e fitto.
Quando fu grandicella, andò a dormire nella cuccia col gatto: acciambellati l'una contro l'altro, siglarono un sodalizio strano, considerata la tradizionale competizione tra le due razze. Quando la cagna usciva, il gatto aspettava nell'ingresso e, al suo rientro, le buttava le zampine al collo e la leccava accuratamente, mentre lei, seduta tutta impettita, lo lasciava fare un po' impaziente un po' lusingata da tanta attenzione.
Quando nacqui io, insorse in moti irrefrenabili di gelosia, rosicando tutto quello che mi apparteneva, dalle scarpine alle pezze, dalla copertina al ciuccio. È comprensibile, avevo invaso il suo territorio. Ma come succede spesso, se da una parte c'era la rivolta verso un intruso neonato la cui presenza non era stata messa in conto e che faceva registrare un netto calo delle solite attenzioni da parte dei padroni, dall'altra nacque un senso di protezione nei miei confronti e guai a quell'estraneo che osasse avvicinarsi! Ringhiava e ululava come un lupo nelle notti di plenilunio.
Essendo io figlia unica, la Nana fu la mia prima amica di gioco e da me si faceva fare di tutto: la mettevo con una cuffia nella carrozzina delle bambole, la portavo sul triciclo con le zampe posteriori sull’asse delle ruotine e con le zampe anteriori sulle mie spalle, finché mamma non diceva: «Povera bestia! Vieni qui, Nana!» e se la riportava in casa al sicuro, così come faceva quando la vestivo da personaggio d'opera lirica e cantavo in giardino le romanze che avevo imparato a memoria senza conoscere il motivo musicale. I vicini si affacciavano alle finestre e si godevano quello spettacolo gratuito sotto lo sguardo mortificato della cagna che sembrava rendersi conto dell'inadeguatezza della sua padroncina.
La Nana aveva abitudini strane, mutuate in parte dalla convivenza col gatto: faceva la pipì con la zampa alzata come i maschi e ricopriva abbondantemente i suoi escrementi con la terra delle aiuole servendosi delle zampe posteriori. Nonno, dalla fine della guerra, aveva passato metà del suo tempo chino a ripulire il terreno, prima dalle macerie più consistenti, poi dai residui sempre più piccoli, aveva piastrellato il giardino, escluse le aiuole da dove la Nana appunto scalciava la terra che finiva sparsa sulle mattonelle. Allora cominciava a urlare: «Nata d'un cane, figlia d'un cane bastardo!», parole che non hanno mai ovviamente offeso la bestiola. Ma quando nonno aggiungeva: «Ora chiamo la lacciaia!», allora abbassava le orecchie, metteva la coda tra le zampe e si rincantucciava nella cuccia tremando come una vetta. Il ricordo di quegli orrendi accalappiacani che giravano per la città e con i lacci afferravano i cani senza museruola e li volavano dentro un furgoncino pieno di latrati strazianti, la terrorizzava. Provare per credere! A lei era capitato due o tre volte di scappare di casa quando era in calore e di essere catturata in quel modo. Riscattata pagando una discreta multa, era tornata mostrando segni evidenti di una grande sofferenza.
Le altre cose che la impaurivano erano i tuoni e i fuochi artificiali: se c'era un temporale, si rifugiava sotto il letto; quando la portavamo lungomare per la festa di Ferragosto, allora andava in collo a mamma e rimpiattava il muso nell'anfratto del gomito, colta da delirium tremens. Ogni tanto le dava una leccatina, come se la pregasse di mettere fine quel tormento.
La Nana amava straordinariamente andare sui motori. Quando ero così piccina che me lo ricordo appena, babbo aveva una moto Norton verde militare dotata di sidecar e di quando in quando andava nella macchia a fare ciocchi per la stufa, portandosi dietro anche la Nana. Partiva con la cagna comodamente sistemata nel sidecar, ma sulla via del ritorno, con il carico lì disposto, l'unica sistemazione per lei era in cima al mucchio dei ciocchi, con le orecchie al vento e la lingua di fuori. Alle curve più secche, perdeva immancabilmente l'equilibrio e partiva a razzo ruzzolando lungo gli argini di campagna. Il recupero non era sempre così facile e talvolta babbo la doveva districare dai cespugli di rovi dove si era cacciata guaendo, non senza qualche ammaccatura. Babbo diceva: «Non ti ci porto più! Questa è l'ultima volta!» L'ebbrezza della velocità era però così forte che lei, zoppicando con dignità, se ne tornava in cima al carico di ciocchi, riprendendo la sua posizione di guardia. Sembrava la piccola vedetta lombarda.
Poi babbo comprò una Vespa celeste metallizzato e il suo posto fu davanti, tra le gambe del conducente. Non si faceva a tempo a portare la Vespa sulla strada, che la Nana era già sistemata, in attesa della partenza. Qualche volta veniva rispedita in casa, cosa per la quale portava un rancore immenso, rifiutandosi di fare le feste a chi era partito, quando faceva ritorno. Pareva che pensasse: «Ora ve la faccio pagare io!». Ma quando le era permesso di venire, sporgeva il muso fuori della Vespa e, orgogliosa della propria condizione di cane motorizzato, abbaiava in continuazione: ai gatti, alle persone, soprattutto alle foglie che vedeva cadere dagli alberi. Di solito la portavamo in campagna, per una strada che allora era sterrata. D'estate, per il caldo, stava con la lingua di fuori, da cui cadevano le gocce di sudore, ma la polvere impastava quella lingua bagnata e quando la Nana decideva che era ora di tirarla un po' dentro, non vi riusciva più e faceva mille smorfie per ammorbidire lo strato pastoso che le si era depositato fino in gola. Noi lo sapevamo e le facevano subito bere una ciotola d'acqua che lappava con avidità.
Almeno se la godeva, la sua vita da cane! Se fosse vissuta oggi, con tutte le limitazioni che ci sono in fatto di traffico animale, sarebbe stata tutta un'altra cosa!
La Nana era comunque una gran viziosa: era golosa in maniera esagerata. Non aveva una sua ciotola per mangiare, ma faceva il giro del tavolino chiedendo bocconcini a questo e a quello: un ossicino, un pezzetto di pane intingolato, qualche brandello di carne callosa. Il tutto inghiottito senza quasi neppure masticare, con la testa alzata in attesa del prossimo boccone. Se la considerazione che riceveva era scarsa, allora si metteva a grattare con le zampe la coscia di qualcuno per richiamare la sua attenzione; di solito a subire il tormentone era mamma.
Non aveva molte pretese, in fatto di cibo: mangiava persino, e con grande avidità, le unghie, quando qualcuno in casa se le tagliava, forse, come ci dissero, per assorbirne il calcio. Soprattutto quando odorava qualcosa di dolce, arrivava di corsa con la classica acquolina in bocca. Qualche volta, per vederne le reazioni esilaranti, le davamo un biscotto inzuppato nel liquore Strega: lei, prima storceva il naso da una parte per evitare che l'alcool le bruciasse quel punto così sensibile, poi ritirava il più possibile le labbra scoprendo i denti coi quali prendeva il biscotto per portarlo nel suo cantuccio e mangiarselo, una volta evaporato l’alcool.
L'evento comunque più atteso era il Natale. Babbo, per risparmiare qualche soldo, mi faceva un albero con un manico di scopa, nel quale praticava dei fori alternati dove venivano infilati i rami di scarto degli abeti veri, doverosamente appuntiti alle estremità. Era praticamente il prototipo dell'albero artificiale e veniva disposto su un tavolo, nell'ingresso. A quei tempi veniva decorato con palle di vetro colorate, molto più belle di quelle attuali di plastica, ma anche molto più delicate e costose, per cui se ne compravano poche e si sopperiva con ciondoli di cioccolato ricoperti di stagnola, a forma di Babbo Natale, di ghianda, di fungo, di pecorella e simili. Una volta deve essere successo che un ciondolo è caduto e finito nelle fauci della Nana, perché trovammo resti di stagnola per terra. Da allora la cagna trascorreva tutto il periodo di Natale sotto l'albero, seduta col muso per aria, in attesa di un'altra caduta miracolosa, sbadigliando rumorosamente per la noia mortale che doveva provare in quel lungo periodo di inattività; ma alla gola non sempre si comanda, specialmente quando si tratta di cioccolato. Si allontanava solo in caso di necessità.
All'inizio degli anni Sessanta cambiammo casa e nella vecchia abitazione rimasero solo nonno e la zia. Si trattava di un ambiente nuovo, più accogliente, più caldo, ma la Nana, come tutti i cani, sentiva la prima come la sua vera casa e spesso scappava e la ritrovavamo davanti alla soglia ad aspettare che qualcuno l'accogliesse dentro per riappropriarsi del suo territorio. Questo non successe e lei, ormai giunta alla veneranda età di quattordici anni, campò poco nel nuovo alloggio.
Morì un diciannove marzo, festa di San Giuseppe, ma era così golosa che prima di spirare, già in agonia, mangiò tre frittelle di riso.
Piansi tanto che mi uscì persino il sangue dal naso.
LA MANNA DAL MARE
(Premio Monte Argentario 1999)
Con le braccia strette attorno alle gambe e il mento poggiato sulle ginocchia, i pescatori del Moletto se ne stavano sulla spalletta, sottovento, con gli occhi fissi verso il mare che in quei giorni era torbido, d’un verde lattiginoso, coperto alla battigia da alghe che andavano a depositarsi in grossi mucchi maleodoranti.
«Chi sa leggere la voce del mare, legge nel cuore della vita» disse Manina, che con quel polso piccolo e piegato dalla poliomielite, non si sa neppure come facesse a buscarsi la giornata, ma che in compenso si dilettava a far filosofia. I Gatti, quattro fratelli salernitani che passavano a turno tre mesi fuori e tre in galera per contrabbando di sigarette e di benzina, annuivano preoccupati anche loro, con la nidiata di figlioli che aspettavano con la bocca spalancata come passerotti appena schiusi.
In quel dicembre del ’52, dopo qualche giorno di dolciura, dove lo scirocco l’aveva fatta da padrone con un’umidità insistente che entrava fino nelle ossa, era girato su ponente e, come dice il proverbio, “Vento di ponente, acqua fino ai ginocchi e pesci niente”. Chi viveva di mare cominciava a tirare la cinghia, in quegli anni già così difficili senza che ci si mettesse anche il tempo a fare il matto.
Qualcuno ne approfittava per riparare le reti, con le dita agili di un folletto, quasi in un gioco che non finiva mai d’incantarmi; qualcuno, mentre sistemava i tramagli, intonava una romanza per tirarsi su di morale, con il risultato che le arie struggenti di Rigoletto o di Cavalleria, finivano per immalinconire anche i più ottimisti; alcuni andavano con le mani in tasca sulla punta del Moletto ad ascoltare più da vicino la voce del mare che brontolava contro gli scogli e non dava pace ai granchi che scendevano e risalivano seguendo il flusso dell’onda.
«Si mette male» disse Pepe mentre dava un morso tra gli occhi di un polpo ancora vivo e cominciava a batterlo sullo scivolo d’approdo delle barche per ammorbidirlo. «Quanto ci scommettete che gira su libeccio?» e fiutava l'aria come un cane che avverte l'usta.
«Si sta benino!» rispose Carmine, uno dei Gatti. «Il libeccio dura tre giorni e lascia il tempo che trova. Quasi quasi mi faccio riprendere, per lo meno quando son dentro mangio tutti i giorni.»
E la libecciata venne, e non se n’era vista una così dai tempi di re Pipino: per camminare, ci si doveva piegare in due contro vento, e se invece lo avevi alle spalle, ti portava in capo le gonnelle e ti spingeva come se avesse furia di passare, tanto che persino i gabbiani restavano appesi al cielo sotto i nuvoloni al galoppo, senza andare né avanti né indietro. Di notte mugolava sui tetti come un concerto di gatti, cento volte di più, e fischiava tra gli spiragli delle case canzonette punto allegre. Sul lungomare, i filobus passavano piano coi vetri opachi dai cristalli di sale e i fili elettrici che improvvisavano fuochi d’artificio fuori stagione. I pini, inginocchiati da decenni di bufere, rendevano alla terra i rami spezzati e qualche tegola volava disperdendosi lungo la strada. Le persiane delle vecchie case, sbiadite dal salmastro, tenute aperte per risparmiare la luce, gracidavano sui gangheri arrugginiti scandendo il tempo come l'orologio dell'inferno.
Babbo mi portava con sé al Moletto stringendomi forte la manina, tante volte il libeccio m’avesse a portar via, e mi metteva sottovento, con il bambolotto di celluloide e un carrettino fatto con i rocchetti di refe.
Quando chiedevo: «Babbo, si va a mangiare?» lui mi rispondeva: «È presto, poi ci si va», ma io sentivo, anche se ero piccina, che era una bugia perché l’ora del desinare me la diceva lo stomaco che protestava, ed era senz'altro quella esatta.
Il secondo giorno di libeccio fu un’apocalisse: le onde arrivavano fin nella strada e non avresti messo il naso fuori nemmeno a pagamento. Soltanto sul Moletto qualcuno se ne stava, con gli occhi stretti e lacrimosi per via del vento, a guardare la Grommet Reefer, una nave americana che da giorni era alla fonda in attesa d’entrare in porto, sballottata di qua e di là come un guscio di noce, pericolosamente vicina agli scogli di S. Jacopo.
La mattina dopo, appena le stelle svaporarono allo spuntare dell’alba, si sentì battere forte alla porta. Il vento era un po' calato e la gente prendeva tregua dopo due notti passate a girarsi e rigirarsi nello scricchiolio dei materassi di vegetale. Era Ugo, detto Civetta perché dormiva più di giorno che di notte, e lui, di solito così parco di parole, cominciò un racconto smozzicato dall’eccitazione, accavallando le parole in balbettii sconnessi, che parlava della Grommet spezzata in due davanti agli scogli di S. Jacopo. L’aveva vista con i suoi occhi, sollevata da un’onda gigante e scaraventata come un fuscello a una cinquantina di metri dalla costa. Fu l'unica cosa che si riuscì a capire.
Babbo gli chiese: «Hai bevuto di mattinata?» e se ne voleva ritornare a letto al calduccio, ma un vocio per la strada lo spinse a infilarsi in fretta e furia i pantaloni e, con gli occhi incollati dal sonno, senza neanche darsi una sciacquata al viso, corse a S. Jacopo, insieme a Ugo, dietro una piccola folla messa in agitazione dalle prime notizie. Lungo la via incontrò anche alcuni amici del Moletto: i Gatti, Bazzina, Ragnolo, tutti allertati e pronti a fare la loro parte.
Ritornò dopo poco: la Grommet era per davvero spezzata in due, come se un diavolo l’avesse centrata con l’accetta e io mi chiedevo come doveva essere grande, l'accetta del diavolo, per tagliare una cosa enorme come una nave.
Sul Moletto si andavano radunando alla svelta le scialuppe dei risi'atori. Babbo si affannava a cercare la mantella d'incerato e il berretto di lana, mentre mamma lo tirava per la maglia, supplicando: «No, questa volta non ci vai! Questa volta ci morite, su quella barchetta!» Ma il risi'atore rischia per definizione la propria vita per salvare quella degli altri, in cambio di qualcosa che può rimediare, e babbo mi prese in collo, mi baciò stringendomi forte per un attimo e poi via, con noi dietro a correre come dannate.
Il Moletto era pieno di gente, i gozzi erano già slegati, le scialuppe imbarcate cercavano di dare un ritmo alle braccia che facevano forza sui remi. Si allontanarono in fila, nell'acqua più calma del bacino, poi cominciarono ad affrontare le onde impazzite del mare aperto tra lo spolverio dorato delle onde nella luce salmastra del mattino, in balia del destino boia della povera gente, mentre i ricchi se ne stavano al caldo nei letti di lana.
Le donne, coi vestiti che sbandieravano al vento, tenevano le mani strette al petto perché non se ne scappasse via dietro alle barche. Qualcuna piangeva, come la mia mamma, e siccome il pianto, come il riso, è contagioso, anche i bimbi si misero a frignare col moccio al naso che pulivano via via con la manica dei cappottini o troppo stretti o troppo larghi. Io alla spalletta non ci arrivavo e non vedevo nulla, così tiravo la gonna di mamma e dicevo: «In collo!», ma lei più di qualche carezza un po' distratta sui capelli non mi concedeva, con gli occhi fissi su quella barchetta che appariva e spariva e non si sapeva se tornava. Qualcuna, senza perdersi d'animo, organizzò una delegazione per andare sul colle a chiedere la grazia alla Madonna di Montenero. Le più anziane, coi rosari in mano, cominciarono una litania che faceva quasi addormentare. Anche qualche vecchio si mise a pregare, senza farsi notare troppo, muovendo appena quelle labbra su cui fiorivano più facilmente moccoli che preghiere. Mi misi in un angolo col bambolotto tra le braccia e cominciai a cullarlo seguendo la litania; doveva essere un momento davvero brutto, se mamma piangeva e tutti guardavano verso il mare e cantavano quella nenia che sapeva di morte.
Ma il diavolo non è così nero come lo si dipinge e qualche volta, oltre alle pentole, fa anche i coperchi: lo disse babbo qualche ora dopo, quando tornò sano e salvo col viso incrostato di salsedine che pareva un Ulisse. La Grommet, che per fortuna non aveva vittime, portava un carico di pacchi natalizi per i soldati americani ancora di stanza sul territorio livornese; erano qualche migliaio e l’America era il paese della cuccagna, così nella stiva c’era ogni ben di Dio: lardo e burro in grosse lattine, pane a cassetta sigillato nelle buste di cellophane, scatole di tonno, tacchini congelati…
La gente cominciò a organizzare il recupero di quel tesoro. Quando i primi tacchini giunsero a riva, così grossi come noi non li conoscevamo, qualcuno si premurò di informarsi cosa fossero, allungando il collo per vedere meglio e, dopo la spiegazione, s’affrettò lungo gli scogli di S. Jacopo, mentre il mare, nel giro d'un giorno, s'era fatto maretta a poco a poco. I più ardimentosi si buttarono in acqua e raggiunsero a nuoto i due tronconi. Intanto la stiva si era riversata in acqua e la superficie torbida si era ricoperta di pacchi e lattine galleggianti.
Babbo, accompagnato da mamma e da me che portavo con una mano una borsa di paglia che strascicava per terra tanto era grande e con l’altra il bambolotto di celluloide, ci sollecitava a camminare svelte: «Sbrigatevi, se si vuol prendere qualcosa. Guardate quanta gente! Non si può perdere un’occasione così!»
Venne persino nonno, che era di campagna e il mare non l’aveva mai potuto soffrire. Andammo verso l’Accademia, dove c’era un braccio di fosso prosciugato, che si riempiva quando il mare si faceva cattivo, e lì la risacca portava di tutto, a cominciare dal legname che tutti gli anni serviva per alimentare la stufa, unica fonte di calore nelle case povere di quei tempi. Ognuno arraffava quel che poteva, tornava a casa con il suo bottino e poi ripartiva per un nuovo carico. Babbo era instancabile e tirava su di tutto, distribuendo anche agli amici, ai vicini di casa che non potevano rifornirsi da soli. Anch’io mi feci spenzolare sull’acqua per prendere qualcosa, ma il bambolotto mi sfuggì di mano e per me la festa quel giorno era bell’e finita.
Il mio primo incarico fu di badare a un tacchino. Somigliava a un pollo, solo era grosso il doppio, con la pelle chiara, sbiancata oltre tutto dalla permanenza in mare che lo aveva scongelato: una massa piuttosto molliccia e gocciolante, senza zampe né testa, che però valeva tant’oro quanto pesava. Voleva dire mangiare a volontà! Ogni tanto lo toccavo con la punta di un dito che ritraevo subito con un senso di schifo.
In casa nostra c’era un giardino, scavato sotto il livello della strada, sul quale si apriva l’ingresso a volta della cantina, un buco stretto e lungo con un pozzo in fondo, che sembrava l’antro dell’inferno. Io avevo paura ad andarci anche di giorno, ma c’era un momento un cui i raggi del sole riuscivano a rischiarare fin là, dove si era accumulata un bel po’ di roba; era il posto più fresco, praticamente il nostro frigorifero. Contavo sulle dita i pacchi, e mi servivano tutte, anzi non mi bastavano nemmeno e mi sentivo ricca perché nonno mi aveva detto che chi possedeva tante cose da mangiare quante erano le dita delle mani, era un bel signore. Lo dissi anche all’asilo, per consolarmi della cucchiaiata mattutina d’olio di fegato di merluzzo, che ingozzavo a fatica con le lacrime agli occhi:
«Tanto io sono ricca! Ce n’ho più di così!» e stendevo bene i palmi delle mani senza fare riferimento all’oggetto del mio orgoglio, perché a qualsiasi cosa mi riferissi, faceva lo stesso il suo bell’effetto.
In realtà molti in città erano diventati ricchi come e più di me e cominciarono a vendere per poche lire quella carne che non si sarebbe potuta conservare a lungo.
A casa si pensò di preparare un pranzo e di invitare i parenti, che scesero tutti contenti dalle colline a piedi, col fiasco del vino sotto il braccio, il pane fresco e qualche dolcetto casalingo. Nel forno della stufa quel pollo sproporzionato non c’entrava: chissà com’erano i forni americani! Fu cotto sopra, per ore e ore, poi i commensali si disposero intorno alla tavola imbandita con la tovaglia bianca che sapeva di lavanda, proprio come in un’occasione eccezionale. Al taglio delle porzioni seguì un’ovazione talmente alta e prolungata che mi fece pensare a una disgrazia, più che a un momento di gioia.
Fu una delusione, tutto sommato: lo scongelamento nell’acqua salmastra aveva dato alla carne un sapore amarognolo di alghe, non proprio piacevole, che si aggiungeva e si fondeva con quello della nafta fuoriuscita dalla nave che aveva invaso una bella fetta di mare davanti alla scogliera. Il pane a cassetta, così dolciastro, invece, stuccava il palato e si preferì dare mano alle belle forme campagnole che odoravano ancora di legna.
Tutti comunque mangiarono in abbondanza quella manna portata dal mare, e qualcosa portarono via, nei fogli di paglia bisunti, per il giorno dopo.
Venne patana, e con il mare liscio come olio i viaggi si moltiplicarono: un brulichio di barchette per caricare legna, ferro, cavi, tutto quello che la nave, con il suo cuore aperto e generoso, poteva offrire alla miseria di quegli anni.
I signori venivano a guardare nei loro cappotti di cammello, affacciati alla balaustra della Terrazza Mascagni insieme alle mogli che rabbrividivano e si scaldavano il naso nei baveri di pelliccia: proprio un passatempo da sfaccendati, con tutto quello che c'era da fare.
Un giorno della prima estate ci andammo anche noi in barca a vedere da vicino: c’erano tanti pesci che facevano a rimpiattino tra le lame arrugginite, e la chiglia era già verde di alghe che ondeggiavano all’acqua come ballerine. Alzando gli occhi verso quel colosso, ebbi paura e mi feci riportare a casa.
Dopo qualche tempo metà della Grommet venne rimorchiata e sparì alla vista; l’altra metà, non si sa perché, rimase abbandonata lì per anni, ridotta a uno scheletro di ferro.
Sul Moletto, nei giorni di tempaccio, si passava il tempo a chiacchiera e non era raro che si commemorassero le imprese più eroiche del recupero della Grommet. Manina continuava a fare i suoi commenti filosofici e i Gatti, con qualche lira sonante in tasca, trascorsero sei mesi interi in libertà.
In casa consumammo a poco a poco quel che si era conservato e babbo, proprio con l’ultima latta di lardo, si ferì una mano, e porta ancora la cicatrice.
Poi fortunatamente i tempi cambiarono, ci furono per tutti gli uomini di buona volontà maggiori possibilità di lavoro e non si patì più la mancanza della carne in tavola, ma ancora oggi i più vecchi si ricordano dell’anno della Grommet come di un anno davvero eccezionale.
Ci avevano fatto anche le cartoline illustrate.
CORRENTI D'ARIA
Caterve di pensionati stanno invadendo l'Italia. È certamente colpa dell'invecchiamento della popolazione, del decremento delle nascite, delle trame governative che minacciano le aspettative di anni di onesto lavoro; sta di fatto che la categoria è in notevole aumento. A parte i problemi dei conti dello Stato, si tratta veramente di una questione sociale, almeno per quanto riguarda una porzione dei messi in quiescenza che, al contrario del termine che ispira l'idea di una tranquilla serenità e di un meritato riposo, è per molti sinonimo di irrequietezza e depressione.
Carlo Rondella è oggi sull'ottantina; quando chiuse il cassetto della sua scrivania per l'ultima volta raccogliendo le sue tre penne biro, la foto del direttore amministrativo e un pacchetto di biscotti ancora intonso, ne aveva poco più di cinquanta, mandato a riposo forzato per effetto di leggi e leggine, servizio militare in tempo di guerra e altri orpelli di cui si è perduto il contenuto.
Più di trent’anni da pensionato! Un colpo mica da ridere per l'INPS! Ma il colpo ferale l'ha ricevuto la signora Alice, consorte del signor Carlo, donna tranquilla, remissiva, condiscendente; se così non fosse avremmo un numero un più nella lista dei suicidi o in quella degli omicidi.
I pensionati, grazie al cielo, non sono tutti uguali: intanto ci sono le donne che, cessato il lavoro extradomestico, hanno comunque, e per il resto della loro vita, da dedicarsi a quello di casalinga a tempo pieno; poi ci sono gli uomini che, a loro volta, si dividono in due categorie: una è quella del pensionato felix, che trova mille maniere per impiegare le giornate, diventate inesorabilmente più lunghe, in mille attività ricreative e non. Sono quelle persone arzille, ben portanti, che coltivano i loro hobby, fanno la partitina a carte, partecipano a gite organizzate, si trovano con gli amici, insegnano ai nipoti (se ne hanno) le cose che sanno fare. In un certo senso, continuano un lavoro anche socialmente utile. Ma il pensionato infelix è una cosa tremenda.
Carlo è senz'altro un infelix. Si vede da come se ne va trasandato nel vestire, con grande cruccio di Alice che si sente responsabile dello stato dei capi di abbigliamento indossati dal marito: «Chi ti vede cosa pensa? Che non ti tengo bene! » dice tutte le volte che lo vede uscire coi pantaloni lisi e il giubbotto pieno di macchie.
Che è un infelix si vede anche da come va in bicicletta, con ondeggiamenti da infarto per gli automobilisti in fase di sorpasso; si vede dalla quantità di viti, bulloni e bullette, di tutte le misure, ordinatamente accumulate in cantina, provenienti dallo smontaggio di elettrodomestici e mobili abbandonati presso i cassonetti dei rifiuti, ufficialmente “perché potrebbero sempre servire”, in realtà perché sono il risultato di una maniera di impiegare un tempo che è annullato, protratto all'infinito, morto; si vede dal fatto che la cantina non trova pace e le tonnellate di oggetti inutili cambiano continuamente la loro collocazione, provocando la comprensibile stizza di Alice che, dove cerca le patate, trova un fascio di stecche da ombrello, al posto dell'acqua scorge appena in tempo un'enorme trappola per topi, se va per una bottiglia di vino si imbatte in un mouse e cavi da computer.
“Quello, nemmeno nella tomba troverà pace!” pensa tutte le volte, senza mai risentirsi per non fare discussioni.
Carlo ha anche defraudato la moglie del sacrosanto diritto di fare la spesa quando, dove e come vuole. Con il pretesto dei prezzi troppo alti nei negozi a conduzione familiare del quartiere, benché non abbia assolutamente problemi economici da affrontare, Carlo va al mercato centrale quasi tutti i giorni e lì si dimostra la sua imperizia: se deve comprare un chilo di mele e quattrocento grammi di acciughe, torna a casa con scorte di frutta degne di un albergo in piena stagione turistica, acquistate a prezzo stracciato perché “leggermente toccate” da imperfezioni marcescenti da cui fuoriescono vermi ben pasciuti, e con una cassetta di pesce vario che finisce regalato a destra e a sinistra prima di buttarlo perché “buttare via qualcosa è peccato mortale”.
«Ho fatto bene?» chiede a conforto ad Alice che sta ai fornelli il triplo di quando i figli non se ne erano ancora andati via di casa.
Alice esce di casa nel primo pomeriggio per raggiungere le sue amiche nel parco vicino, mentre Carlo sonnecchia sul divano. Non ha neppure il tempo di sedersi sulla panchina e di dire: «Ah, bene!» che ecco arriva lui che, per ammazzare il tempo, si piazza nel gruppo di donne, privandole del diritto, pure sacrosanto, di parlare male dei loro mariti.
«Non te la prendere, Alice. Sono tutti uguali, te lo dico io!» dice Marta per consolarla, non appena sono sole.
«Ma perché non ti fai sentire?» la incita, più battagliera, Rosa.
Alice scuote la testa: nessuno può comprendere fino in fondo tutta la sua sofferenza, la sua pena scontata giorno dopo giorno senza prospettiva di una soluzione.
Carlo appartiene alla categoria dei pensionati che, sentendosi inutili, ripetono in continuazione: «Non vedo l'ora di morire. Cosa ci sto a fare al mondo?»
È un quesito esistenziale mica da niente e, detto scuotendo sconsolatamente la testa, suscita preoccupazione in chi gli sta accanto, salvo poi dimostrare un attaccamento alla vita tipico di un ventenne. Se ha trentasette di temperatura, interpella tre o quattro medici, definendoli incompetenti quando gli dicono che si tratta di un semplice raffreddamento, che non è nulla di grave, che si riguardi qualche giorno e tutto passerà.
Quando sente la parola “raffreddamento” entra subito in fibrillazione: suo padre, negli anni Venti, ebbe la tubercolosi, e questo fatto ha leso definitivamente i rapporti di Carlo con l'aria. Se non fosse che bisogna respirare per forza, l'avrebbe senz'altro eliminata dalla faccia della Terra. Sente correnti e spifferi dappertutto e, benché abbia una salute di ferro, bontà sua, ha un sacro terrore della tosse: sua figlia da piccola, doveva andare a tossire in cantina, se non voleva sentire il padre rimproverare la madre: «Perché hai fatto prendere fresco alla bimba? Senti lì che tosse! Dove l'hai portata?»
Alice tenta una difesa disperata prima di arrendersi per ascoltare, per la milionesima volta, il decalogo di Carlo sulla prevenzione contro i malanni. È per questo motivo che la bimba non è mai andata oltre un triciclo, non ha mai saputo saltare con la corda, giocare a palla, pattinare come le sue spensierate compagne. Il fratello, in quanto maschio, ha avuto più fortuna e, per il fatto che faceva sport, ha avuto la concessione di qualche raffreddore in più perché “a fare sport si suda”.
Pronunciare il verbo “sudare” all'aria aperta è blasfemo come bestemmiare in chiesa. Figurarsi come deve essere stata per alcuni anni la vita di un'Alice in menopausa!
Anche quando tutto è chiuso, Carlo fissa Alice con sguardo accusatorio e dice: «C'è corrente».
Lei ha provato a convincerlo di respirare tappandosi una narice, perché l'unica corrente concepibile può essere provocata dall'attività contemporanea dei due buchi del naso, ma non c'è stato nulla da fare.
L'ultima sua vittima, in ordine di tempo, è il nipote universitario che spesso va a studiare in casa dei nonni. Poiché nella stanza dove si piazza, d'estate batte il sole tutto il pomeriggio, il ragazzo si è comprato un piccolo ventilatore. L'avesse mai fatto! Il nonno si affaccia continuamente alla porta, infilando solo la faccia e grida: «Attento con quel coso! Lo senti che vento? Ti prenderai una polmonite!»
Il nipote fa gli scongiuri del caso e continua a fare il comodo suo.
Infatti, se d'inverno le manie per le correnti d'aria di Carlo sono sopportabili, d'estate diventano terrificanti. Carlo, eccetto quando esce, con tutte le cautele possibili e immaginabili in quanto riesce a sentire correnti anche in spazi aperti come il porto, d'estate instaura un regime da separati in casa e vive in perfetta solitudine, con la porta e la finestra chiuse in salotto, dove Alice non osa andare a guardare la televisione se non dopo che Carlo se ne va a dormire. Un giorno, con quaranta gradi all'ombra, infatti ha detto in tono gelido: «Smetti di sventagliarti quando ci sono io, fai corrente» e quindi a lei non rimane che boccheggiare sul terrazzo, dopo essersi accuratamente chiusa la porta di cucina alle spalle. Ovviamente dorme sul divano, con la finestra spalancata, da giugno a settembre.
Fortunatamente Carlo non è un tipo ciabattaro, per cui esce in tutte le stagioni e, se fa brutto tempo, se ne va a spostare la cantina. Comunque i preparativi invernali per le sue uscite in bicicletta sono un rito: flanella di lana sulla carne in pendant con mutande lunghe pure di lana (quasi introvabili su un mercato a disposizione di clienti incoscienti che vestono agile e sportivo), giornale ripiegato sul petto, pantaloni pesanti, maglione, golf, giubbone imbottito, sciarpa, cappello con paraorecchie di stoffa impermeabile e ovviamente con l'interno di pelo sintetico. Somiglia straordinariamente a uno Yeti. Tempo fa Alice ha saputo che, poiché con il vento gli lacrimano gli occhi, sopra gli occhiali indossa una maschera da sub a mo' di sigillo. Se usasse anche il boccaglio probabilmente andrebbe a vapore.
Dove va così conciato? A una spedizione polare? No, solo a fare dei giri senza una meta precisa, dato che non frequenta bar dove si urla troppo, non sopporta di sentir parlare di sport, non vuole discutere di politica, non ama né cinema né teatro, odia andare in centro a passeggiare, ha centinaia di conoscenti ma nemmeno un amico da frequentare.
L'unico essere umano che è riuscito a sopportarlo è Alice e del resto gli errori di gioventù, prima o poi, si pagano. Tra l'altro, dal giorno della pensione, le ritenute IRPEF, l'ICI, la tassa Fiumi e Fossi, l'imposta sui rifiuti, le bollette di gas, luce e telefono, occupano tutte le sue fantasie erotiche e passionali.
Questa è la vita, minuto più minuto meno, del pensionato Carlo Rondella e di chissà quanti altri. Se ne può trarre la conclusione che il cosiddetto “fine trattamento di lavoro” significa purtroppo per molti “fine trattamento di vita”.
BANDIERE ROSSE
(Premio Ippogrifo 1998)
Un vestitino scollacciato su due gambe pienotte che ancora non evocavano l’immagine di due prosciutti come ora; un vitino, non di vespa, ma che accentuava i fianchi pronunciati e il busto proporzionato che sinceramente non si poteva ancora definire un armadio; le spalle dritte su cui pioveva una pioggia di capelli allora castani: così ero a vent’anni, un tempo che mi sembra già preistoria.
Trascorrevo le mie vacanze estive a Varese, dove avevo contatti con alcuni compagni della Federazione comunista, giovani come me. Anche il Partito era giovane, nel senso che nell’avanzato Nord viveva ancora negli anni Settanta il periodo della clandestinità, mentre imperversava il fascismo: scritte inneggianti il Duce, attentati, bombe a mano e via dicendo. Ma almeno era vivo, la gente aveva una fede, lottava, si dava da fare. Ora, invecchiato come vuole la legge di Madre Natura, si è seduto come un commendatore in doppiopetto e sicuramente c’è qualcuno che gli lega le scarpe.
Presa dall’euforia del nuovo ambiente, sfoderando tutto il mio repertorio linguistico di toscana purosangue, scorrazzo giorno e notte da un paese all’altro della Brianza, là dove fioriscono le Feste dell’Unità e dove ormai sono diventata un personaggio popolare, tanto più che vengo da una città 'rossa' per tradizione. Mi chiamano 'la Livornese’, avendo io rifiutato di sentirmi apostrofare 'Daniela' con quella ‘e’ chiusa che mi provoca crisi di identità.
Sulla macchina del partito siedo davanti, accanto al Ruggieri, responsabile della FGCI, capelli ricci e barba alla Che Quevara e dietro di me siede il Lucchina, detto Lucca, tuttofare, in eskimo da combattimento con cui vive in perfetta simbiosi, estate e inverno.
Nel bagagliaio, dimenticate con incredibile superficialità, giacciono le bandiere rosse con tanto di falce e martello, smontate il giorno prima da una Festa dell’Unità.
La macchina percorre le strade linde verso la borghesissima Svizzera, dai prati perfetti senza nemmeno un foglino piccino così; fa schifo, questa Svizzera inverosimilmente linda e conservatrice. L’unico pregio è che vende sigarette e benzina a basso costo. E pertanto, in barba agli ideali marxisti, si va là a fare il pieno quasi tutti i giorni.
La frontiera è un paesino così minuscolo da entrare tutto in un francobollo, è frequentato solo da habitué e tutti si conoscono: doganieri e contrabbandieri, frontalieri e guardie svizzere. Le guardie svizzere sono giovani, dall’aspetto inconfondibilmente montanaro, irrigiditi nelle divise grigie e cappello cilindrico a visiera del tipo “Bene, io ti vedo e tu no!”.
Nell’aria sonnolenta di metà agosto il Ruggieri trova la forza di lanciare un moccolo irripetibile, rivolgendo improperi sia verso se stesso sia verso il Lucca che fa: «Ti uì, ti dà fora de matt?»
E giù in un velocissimo sproloquio, in cui riconosco solo poco più di qualche parolaccia. Io guardo l’uno e l’altro, come nelle partite di tennis: capisco un terzo di quello che dicono. Finalmente il Ruggieri si decide a comunicarmi che le bandiere rosse lasciate nel portabagagli sono un pericolo per noi: la macchina è conosciuta alla frontiera come macchina del Partito e spesso viene perquisita; in Svizzera è severamente proibito fare propaganda comunista; insomma, che mi prepari a essere fermata per accertamenti, se decidessero di aprire il portabagagli.
Bella mi’ Livorno, senza fascisti, senza frontiere, senza svizzerotti ottusi, dove le bandiere rosse potevano viaggiare con assoluta tranquillità!
«Ma dove m'avete portato, scimuniti che non siete altro!» dico, subito allarmata.
Siamo già arrivati alla dogana; si avvicina la guardia, mentre io mi vedo già carcerata nelle efficientissime carceri svizzere, perseguitata politica, soprattutto messa a pane e acqua. Nel battibeccare col Ruggeri il vestito mi è salito sopra la coscia e mi accorgo che lo svizzerotto, dopo aver fatto il giro della macchina squadrandola da tutti i lati, si è avvicinato al mio finestrino e guarda proprio lì, le mie gambe, mentre si scosta un po’ la visiera del cappello dalla fronte, come chi vuole prendere aria alla testa.
Comincio a farmi vento con la mano, facendo finta di avere un gran caldo, mentre in realtà un sudore ghiaccio mi ricopre da capo a piedi e sento anche i capelli rizzarsi leggermente in testa. Poi, come se la mano non bastasse, comincio a farmi vento col lembo del vestito, scoprendo ancora di più quello che in tempi normali non mi sarebbe nemmeno passato per l’anticamera del cervello di mostrare a uno svizzerotto mangiapatate con le gote rosse e la faccia da ebete.
La guardia si toglie il cappello e si sventola a sua volta, forse per la prima volta in vita sua durante il servizio.
Mi guarda, lo guardo. Io zitta, lui zitto. E ora? Cosa posso ancora escogitare? La mente turbina tra mille possibili soluzioni: svenimento tipicamente femminile con molle abbandono del corpo sul sedile (ma non sono mai stata una brava attrice e poi nei momenti strategici mi prende sempre un tremendo prurito al naso); improvvisata denuncia contro il Ruggeri e il Lucca di sequestro di persona a scopi politici (ma in borsa ho la tessera del Partito); crisi isterica con urla supersoniche e copiosa fuoriuscita di lacrime a comando (ma attirerei l’attenzione di non so quanti Svizzeri).
La ricerca affannosa mi toglie la lucidità necessaria a mettere a fuoco un piano razionale, mentre il naso del giovanotto si affaccia al finestrino, seguito da due occhietti sempre più svegli e attenti. È la fine! Sprofondo sul sedile, in attesa di ordini, con un sorrisino forzato sulle labbra quale ultimo tentativo di mitigare la sentenza, di distogliere l’attenzione da quel fottutissimo portabagagli dove dormono placide le fottutissime bandiere rosse.
L’attimo di panico faccia a faccia con lo straniero pare durare un secolo; mi sento tanto un'eroina destinata a sacrificarsi in terra nemica per difendere l'amore della Patria. Poi fortunatamente lo svizzerotto viene chiamato da un collega, fa cenno di proseguire e si allontana tutto d’un pezzo, ripiazzandosi il berretto in testa.
Il Ruggeri e il Lucca restano lì impalati a guardarmi, come se lo spettacolo non fosse ancora finito, mentre io urlo: «E spicciati, metti in moto! »
La sbarra della dogana è alzata, fuori c’è la salvezza! Un sospiro di sollievo mi vuota completamente la testa, il cuore torna ai ritmi consueti. Fuori da ogni logica idealistica, mi riprometto di portare al più presto un cero alla Madonna di Montenero.
ANTENATI E DINTORNI
I miei antenati e i loro compaesani erano rappresentanti di un'umanità varia, accomunati dall'origine contadina, abitanti di paesini grandi come fazzoletti, costituiti da poche case dove tutti sapevano tutto di tutti e potevano dormire con le porte aperte. Per me, che sono nata in città, hanno sempre rappresentato oggetto di curiosità e di attenzione in tutti i loro aspetti, a partire dai coloriti soprannomi che erano già di per sé tutta una storia. Pur non brillando dal punto di vista dell'intelletto a causa dei numerosi matrimoni contratti tra parenti, certi personaggi sono rimasti impressi della memoria e ancora oggi in famiglia se ne tramandano gli aneddoti così come si raccontano le barzellette a veglia.
Cenate era un omone grande e grosso, dotato di una forza incredibile e di mestiere faceva il barrocciaio. Lo chiamavano così perché, vivendo solo, quando la sera tornava stanco dal lavoro, si affacciava alla porta di qualche vicino e diceva: «Cenate? Allora resto anch'io» suscitando immediata apprensione nelle massaie che già avevano fatto i salti mortali per procurare alla famiglia un pasto degno, come quantità, di essere chiamato tale. E Cenate poi non è che si riempisse con una fetta di pane e un bicchiere di vino: mangiava come un bove, anche se si contentava dei cibi semplici che gli venivano messi sotto il naso.
Del resto come si fa a dire di no a un compaesano? Ma non sempre la gente era disposta a ospitarlo, allora a volte le famiglie procuravano di anticipare i pasti o di trascorrere un'oretta in silenzio e in completo oscuramento, finché Cenate non avesse trovato ospitalità presso qualcun altro: non avrebbe mai osato entrare in una casa che non desse segni di vita.
Una volta, quando avevano appena installato il semaforo sulla strada che percorreva al ritorno dalla città, era alla guida del suo barroccio ancora carico di fascine e si accingeva a fare le ultime consegne, tenendo le redini del cavallo che camminava stanco, con la testa ciondoloni. Non conoscendo il significato simbolico di quell'aggeggio che penzolava da un filo in mezzo al crocevia, passò col rosso. Il vigile, solerte, fischiò subito, ma Cenate imperterrito continuò sulla sua strada. Il vigile fischiò ancora e poi di nuovo contro quel conducente indisciplinato e indolente di fronte alla sua autorità. A quel punto Cenate, con tutta la calma possibile, si girò e disse: «O vigile, l'ho visto! Non vi preoccupate, l'ho visto! Non ci sbatto, no!» e continuò la sua strada dondolando, seduto in cima al carico del suo barroccio.
Fiammone era altrettanto grande e forzuto, abbrutito dalla fatica. Una volta si era caricato sulle spalle un marmo e lo doveva portare all'Hotel Palazzo, che a quei tempi ospitava tanti personaggi importanti e quindi veniva via via restaurato come si deve. Dopo aver salito una rampa di scale con quel peso addosso, arrivò su un pianerottolo decorato alle pareti da specchi. Fiammone, vedendo l'immagine di un uomo che portava un marmo sulle spalle, si fece da parte, ma non vide passare nessuno. Allora fece di nuovo due o tre passi avanti, ed ecco che quello ricompare. Fiammone gli dette di nuovo la precedenza, ma senza risultato. Alla terza volta, tornando a vedere l'immagine di se stesso nello specchio, disse a quell'uomo senza creanza che lo teneva lì con quel carico sulle spalle: «Senti, deciditi: o passi o passo.»
La Dolinda, al contrario, era un donnino piccino piccino, ed era la scema del paese, da quando l'arteriosclerosi le aveva fatto perdere la coscienza. Se ne andava per la strada camminando svelta rasente i muri, con la testa piegata da un parte. Tutti comunque la rispettavano e la salutavano quando passava: «O Dolinda, come va?» anche se nessuno si aspettava da lei una risposta.
Un bimbetto però, quando la vedeva, la guardava con curiosità e forse con un po' di paura mista a compassione. Un giorno chiese al padre: «Babbo, ma cos'ha la Dolinda?»
«Poverina, ha perso il cervello.»
«E dove l'ha perso? »
«Eh, l'ha perso nella macchia della Tanna» rispose il padre per mettere fine a ulteriori richieste di spiegazioni che non avrebbe saputo dare.
Il bimbo ci pensò per qualche giorno e poi propose:
«Babbo, domani che è domenica, perché non si va nella macchia della Tanna a vedere se si trova il cervello della Dolinda?»
«Si può provare,» rispose il padre «ma è grande e ho sentito dire anche che c'è l'Orco che gira da quelle parti. Comunque, domani fatti svegliare presto e ti ci porto.»
Naturalmente l'indomani mattina il bimbo disse che aveva il mal di pancia e non si poteva mettere in cammino. Si può imbrogliare così l'ingenuità e la generosità di un bambino?
Benché, per ragioni economiche, si facesse di tutto per non ricorrere alle cure di un medico, Pitone si sentiva troppo male: tossiva in continuazione, era smagrito, non si reggeva sulle gambe, perciò si decise a rivolgersi al dottore che lo girò e lo rigirò da tutte le parti e infine sentenziò: «Questa è pleurite» e per farsi intendere meglio aggiunse: «C'è l'acqua nei polmoni».
Pitone lo guardò stranito e disse: «Con tutto il rispetto, ma che dite, dottore? A meno che non mi ci sia entrata quella volta che mi fecero lavare per forza gli orecchi da soldato, vi pare possibile che io ci abbia acqua nei polmoni? In bocca mia, ve lo posso garantire, non c'è entrato mai altro che vino!»
Lo Gnudo faceva il taglialegna ed era un tipo un tantino suggestionabile, così un giorno i suoi compagni decisero di fargli uno scherzo. Una mattina, avviatosi come sempre verso la macchia con una cipolla e mezzo pane nel fagotto della colazione, camminava svelto per raggiungere la sua squadra di lavoro, quando incontrò un gruppetto di compaesani.
«Salve, Gnudo, come va?»
«Bene, bene.»
«Ma sei stanco, stamattina? Non mi sembri tanto in forma.»
«No, no, veramente non ho proprio niente.»
Si salutarono e lo Gnudo proseguì per la sua strada.
Dietro una curva del viottolo, lo aspettavano altri due o tre.
«Ehilà, Gnudo, com'è?»
«Bene, perché?» - rispose lui, già un po' più guardingo nel dare risposte sul suo stato di salute.
«No, così, mi sembra che tu abbia qualcosa che non va.»
«Ma cosa volete che abbia? Sono il solito di sempre.»
«È che ci hai un visaccio… Mi garbi poco.»
«Vi dico che non ho niente.»
«Va bene, Gnudo, meglio così. Ci si vede, eh?»
Lo Gnudo, rimasto solo, cominciò a tastarsi il viso, con la fronte già un po' aggrottata dalla preoccupazione, poi fece una spallucciata e proseguì per la sua strada. Dopo un po' ecco apparire altri due.
«O Gnudo, mamma mia che faccia hai!»
«Perché, che faccia ho?» chiese con tono allarmato.
«Tu ti vedessi! Ma te ti senti male!»
«Me l'hanno già detto, ma io non mi sento nulla» e la voce tremava leggermente.
«Guarda, se vuoi un consiglio, tornatene a casa e riguardati perché non stai per niente bene. Noi ti s'è detto, poi fai te!»
Lo Gnudo a questo punto non ci pensò due volte: girò le spalle, andò di corsa a casa e alla moglie, meravigliata che fosse ritornato così presto, ordinò: «Moglie, preparami subito il letto, ché ci devo andare di volata. M'hanno detto che mi sento male.»
Dallo spavento gli venne un febbrone da cavalli e se la cavò per miracolo.
Era usanza, quando un vedovo passava a seconde nozze, o quando uno scapolo si accompagnava con una vedova, che un gruppo di paesani andasse la sera sotto le sue finestre a far la scampanata, sbattendo coperchi e pentole e provocando più fracasso possibile per ottenere un rinfresco da consumare in onore degli sposi. Così, quando Geffito, detto “il Generale”, si sposò, gli toccò sorbirsi quel tradizionale festeggiamento. Pare che la moglie tenesse stretti i cordoni della borsa, ma i paesani non si dettero per vinti e, in gruppo sotto la finestra si misero a cantare:
Se il Generale non ci dà da bere,
la scampanata per nove sere.
Se il Generale non ci dà un confetto,
la scampanata per dispetto.
Non ottenendo ancora risposta, la sera successiva tornarono a cantare, cercando di pungerlo sul vivo, ferendo il suo orgoglio di maschio:
Il Generale l'ha fatta la più bella:
s'è levato i pantaloni e s'è messo la gonnella
E te che sei General de’ Bersaglieri,
ti sei fatto levar la chiave del ciglieri.
Alla moglie questa trovata non dispiacque e lo fece sapere, in qualche modo, agli amici del marito che si presentarono ancora e questa volta si rivolsero alla moglie:
voi ci avete piacere, noi ci abbiamo gusto,
domani sera si porta anche quelli di San Giusto.
Di fronte al pericolo di vedersi arrivare altra gente ad accampare pretese, la donna aprì subito la porta, fu offerto il rinfresco e fatta la pace.
Nonno Nanni che era il mio bisavolo, nonno di mio padre, decise di mandare a scuola Cecco, il figlio minore, cosa più unica che rara per quei tempi in un paesino di poche famiglie che vivevano del lavoro della terra, con il contributo di tutti, grandi e piccoli. Il certificato “degli esami di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare inferiore”, che reca la data del 1904 e la firma del Regio Ispettore scolastico del circondario, riporta questi punti espressi in decimi:
Prove scritte
Componimento italiano: sette
Scritto sotto dettatura: nove
Problema: nove
Calligrafia: sette
Prove orali
Lettura con riassunto delle cose lette: sei
Aritmetica pratica: sei
Storia, geografia, diritti e doveri del cittadino: sette
Segue la media dei punti:
Negli scritti di lingua (illeggibile)
Nella lettura, ecc. : sei
Nell'aritmetica: otto
Nella storia, geografia, diritti e doveri del cittadino: sette
Nella calligrafia: sette
Nonno Nanni era profondamente religioso, nonostante i moccoli che tirava in continuazione e, visti i risultati abbastanza soddisfacenti ottenuti da Cecco, orgoglioso di lui, lo mandò a proseguire gli studi dal prete per vedere di offrirgli prospettive di una vita migliore.
Cecco cominciò a frequentare, ma si accorse che le aspettative andavano continuamente deluse: si aspettava da un uomo di chiesa pazienza, comprensione, dolcezza, ma trovò una realtà completamente diversa. Frequentò per un po', ma il giorno in cui per punizione il prete lo mise per due ore con i ceci secchi sotto le ginocchia, scappò e non si fece più vedere.
Forte della sua cultura, però, non si lasciava mai smontare da nessuno e se, per esempio, si parlava della posizione geografica di una città e le affermazioni discordavano, messo di fronte all'oggettività ineccepibile di un atlante, non esitava a proclamare: «Hanno sbagliato. »
Comunque fu lui, nonno Cecco, che mi insegnò a leggere e scrivere, quando avevo quattro anni, mettendosi accanto a me e facendomi tenere il quaderno obliquo, come usava ai suoi tempi.
Anche nonno Nicodemo era il mio bisavolo, nonno di mia madre, che io non ho conosciuto, ma di cui ho sempre sentito parlare. Per campare faceva il calzolaio, con il suo banchino davanti all'uscio di casa e, quando pioveva, sotto la cappa del camino dove le fiamme illuminavano maggiormente la cucina. Le case non erano ancora dotate di impianti elettrici e oltre tutto si doveva risparmiare sulle candele o sull'olio, come dice anche il proverbio “Bonanotte Gesù, ché l'olio è caro”.
Nonno Nicodemo confezionava e riparava scarpe per tutto il paese e anche per il circondario perché era molto abile nel suo mestiere e, da questo punto di vista, mia madre e le sue sorelle avevano una gran fortuna: il 21 marzo tutti, per risparmiare, si toglievano le scarpe e camminavano scalzi fino a ottobre, eccetto la domenica o per scendere in città. Si diceva infatti “A marzo chi ha bella gamba vada scalzo”; invece le nipoti di nonno Nicodemo potevano contare anche nella bella stagione su qualche paio di zoccoli, con la suola di legno e la tomaia fatta di ritagli di pelle. Dopo la sua morte, anch'esse dovettero camminare per le strade sterrate con calli alti un dito sotto i piedi.
Ma nonno Nicodemo era famoso soprattutto perché sapeva cantar di poesia. Sembrava che pensasse in rima perché qualsiasi occasione era giusta per tirar giù versi a rima incatenata, alternata, baciata, in terzine, in ottave di settenari, endecasillabi e chi più ne ha più ne metta. Era un autodidatta, innamorato soprattutto dell'epica cavalleresca, tanto che conosceva a memoria tutta “La Gerusalemme Liberata”, ma sapeva anche di Dante e di altri poeti. Ai sette figli aveva dato nomi di tradizione classica: Omero (detto Mario), Ludovico (detto Dolo), Virgilio (detto Giglio), Elettra, Vetulia, Clelia, Teodolinda. Spesso componeva su commissione, ma più che altro lo faceva per sé, per la famiglia, per il paese. In occasione delle feste religiose, lo chiamavano anche dai paesi vicini e, nel suo piccolo, si era fatto un nome.
Come tutti, del resto, era un fervido credente e conserviamo ancora un manifestino stampato intitolato “I miracoli operati a Lourdes descritti in ottava rima da Cecconi Nicodemo”. Vi si parla di una sua nipote, Corinna Mazzoncini che, ingessata fino ai fianchi, si recò in Francia e tornò a casa risanata. Insieme a lei partirono da Livorno altre cinque persone, tra cui un cavatore che aveva avuto un occhio sfracellato da una mina. Ma si tratta più che altro di una lode alla Madonna, come nonno Nicodemo dichiara in fondo:
Or mi sono annoiato a più non posso:
Il comporre per me troppo è tedioso.
Feci uno sforzo e scrissi in poesia
Per venerare il nome di Maria.
Un appuntamento fisso con la poesia era vicino a Pasqua, quando mandava i figli dalle massaie a raccogliere gli ingredienti necessari a confezionare la sportellina, il tradizionale dolce toscano che si mangia per commemorare, allora più che ora, la Resurrezione di Cristo. Ognuno aveva il suo pezzettino da recitare e se ne partiva la mattina presto in cerca di cuori generosi. Io ricordo a memoria quello di Dolo (Ludovico):
Son piccolino, non posso andar lontano,
mi contento girar per il paese.
Vi chiedo un uovo, non è caso strano,
anche se di gallina bugginese.
Mi contento di farne una dozzina
almen per assaggiar la sportellina.
e quello di Giglio (Virgilio) che, essendo il minore, aveva solo una particina:
Io sono Giglio
e se mi date un ovino, me lo piglio.
Nonno Nicodemo, classe 1851, abitava con il figlio Omero, forse quello più sfortunato, reso mezzo cieco e asmatico dai gas usati nella Prima Guerra Mondiale sul fronte francese, e che aveva a sua volta sette figli. Nonno Omero non aveva molte energie per lavorare e campava con quello che rendeva un piccolo appezzamento di terra, compensato dai guadagni, anch'essi scarsi, dei figli, quando furono in età di lavorare. Purtroppo ci si misero di nuovo le guerre d'Africa e Mondiale e i nipoti di Nicodemo si sparpagliarono per il mondo con la divisa e il fucile a tracolla, restando lontani per anni. Ma in tempo di pace, quando si mettevano a tavola erano in dieci: si contentavano di pane, che non mancava mai, qualche noce, mezza acciuga, patate, fagioli, uno spicchio d'uovo, con la mamma che sembrava la chioccia del pollaio e mangiava in disparte, nell'angolo del camino. Omero invece aveva i suoi pranzi speciali, come una manata di chiocciole buttate a cuocere tra la cenere e mangiate così, senza alcun condimento, o un topino di macchia abbrustolito. La carne dal macellaio Agapito, che veniva in paese due volte la settimana, si comprava solo se qualcuno si ammalava: un pezzetto di lesso grosso come una polpetta, da mangiare nei due giorni di convalescenza, perché finché durava la febbre, digiuno!
Quando uno dei nipoti era soldato, nonno Nicodemo gli scrisse una lettera che cominciava così:
Non vedo l'ora di averti vicino,
Caro nepote, ma se quando torni
A me si dessi per brutal destino
Di aver compiuto ormai l'ultimi giorni
E cader nelle mani del becchino,
Perdon ti chiedo e non ti chiedo 'l pianto
Ma una fervida prece al Camposanto.
Nonno Nicodemo morì quindici giorni dopo aver scritto la lettera, nell'agosto del 1933. Si sentiva vicino alla fine, tanto è vero che aveva già espresso le sue volontà per il funerale:
Riposa, o fredda spoglia, insiem con l'ossa
Fino al dì del Giudizio Universale
Che spalancata ti verrà la fossa
E quindi giudicato il bene e il male.
Or di ogni colpa mia piccola o grossa
Chiedo perdono al Giudice Immortale,
Chiedo perdono affinché io possa
Verso l'Eliso spiegar dritte le ale.
Ringrazio tutti quei che al mio trasporto
Venner devoti, accompagnar la salma.
Piccol ghirlanda, allor che sia morto:
Né fior, né lumi dan la pace all'alma.
Ci vuol la prece come Iddio nell'orto
E il sonno eterno troverà la calma.
Mi sarebbe davvero piaciuto conoscere di persona un uomo così, con il suo banchino di lavoro davanti la porta di casa, che quando lo salutavi, ti rispondeva con tre o quattro versi detti all'impronta, continuando a picchiare sui chiodi dei tacchi; sinceramente ti poteva dare allegria per il resto della giornata.oi fortunatamente i tempi cambiarono, ci furono per tutti gli uomini di buona volontà maggiori possibilità di lavoro e non si patì più la mancanza della carne in tavola, ma ancora oggi i più vecchi si ricordano dell’anno della Grommet come di un anno davvero eccezionale.
Ci avevano fatto anche le cartoline illustrate.
SENSI DI COLPA
Le tre del mattino. Tra poco più di un’ora Laura si sarebbe alzata e avrebbe avuto inizio la grande avventura. Incapace di dormire, ripassava le tappe del suo progetto: si era fatta scrivere da Silvana, l’amica di Milano, per farsi invitare a una fantomatica vacanza di una settimana in Svizzera. La presenza della madre di Silvana costituiva una garanzia per i genitori di Laura, così poco propensi a concedere libertà alla figlia, nonostante i suoi vent’anni suonati, e così avevano acconsentito a questa vacanza, pensando che potevano contare su un adeguato controllo.
L’avessero saputa tutta! In realtà Laura stava per partire con il suo ragazzo, Luca, e con una coppia altrettanto clandestina, Renzo e Giuliana. La vera destinazione del viaggio era un campeggio a Luino, sul lago Maggiore, vicinissimo alla frontiera svizzera.
Attraverso le stecche della serranda, il fascio di luce del faro si abbatteva con regolarità sugli occhi sbarrati di Laura che ogni volta sobbalzava come sotto la luce impietosa della polizia negli interrogatori che aveva visto in tanti film americani.
E se qualcosa fosse andato storto? Quante volte era stata sul punto di rinunciare! Ma sempre aveva cacciato il senso di fastidio che le procurava la paura di essere scoperta. In fin dei conti era ormai una donna, e poi era troppo importante partire: si trattava del viaggio della sua vita, quello che l’avrebbe messa di fronte alla possibilità di un vero amore.
Tra poco. Tra poco avrebbe sperimentato il gusto del rischio, della trasgressione, e il pensiero le dava delle trafitte alle estremità delle dita, come sempre quando provava una forte emozione, un’ansia particolare.
Le tre e venti. Il tempo scorreva lento, quasi bloccato dalla volontà di Laura di ritardare quel momento quando, scesa dal treno diretto a Milano, sarebbe salita sull’auto sportiva di Luca e via, verso la vita!
E se, per caso, fosse successo un incidente? E se Silvana si fosse in qualche modo lasciata sfuggire qualcosa con qualcuno che poteva riferirlo ai suoi? E se qualche livornese avesse avuto la malaugurata idea di andare in vacanza da quelle parti?
Il letto era diventato un’urna di fuoco, il sudore appiccicava le lenzuola al corpo, dalla finestra non entrava un alito di vento: in quella mattina di mezz’agosto anche la natura pareva in attesa e partecipe del suo stato d'animo.
Laura non vedeva l’ora che suonasse la sveglia. Ma perché non riusciva a chiudere occhio? Chissà come sarebbe stata stanca per tutto il giorno! Invece aveva bisogno di apparire briosa, allettante, disponibile; ne andava del suo futuro.
Le quattro e mezzo. La sveglia suonando fece sobbalzare Laura come una sentenza di colpevolezza. Era fatta. Si alzò e andò in cucina. La mamma aveva già preparato il caffellatte con i biscotti, il babbo era già sceso a controllare la macchina. Tutti erano al loro posto, occupati nelle loro mansioni; solo lei si sentiva fuori dal mondo che le era abituale, un'estranea capitata lì per caso.
Mangiò svogliatamente e cominciò a prepararsi, mentre la mamma andava attorno per le ultime incombenze.
«I fazzoletti li hai presi? Porta un golf pesante, non si sa mai... Ah, quell’indirizzo della Svizzera?» Un tuffo al cuore. Non l’aveva, logicamente, un indirizzo in Svizzera.
«Uffa, mamma, te l’ho già detto che ancora non sappiamo a quale albergo scenderemo. Te lo dirò per telefono.»
Chissà poi cosa avrebbe inventato! Ad allungare la catena di bugie ci avrebbe pensato insieme agli altri, ormai suoi complici, del resto.
Arrivò l’ora di partire. Il padre l’accompagnò fin sul treno, sistemò la valigia e aspettò che partisse. Fortunatamente ebbe il buon gusto di non affidarla a qualche passeggero, come quando era piccola.
Appena la Freccia Azzurra si mosse, ci volle un respiro profondo per riequilibrare le emozioni scomposte che si agitavano dentro di lei.
A Pisa scese. Come d’accordo, nessuno era in stazione ad attenderla, per evitare che qualcuno dal treno vedesse. Uscì sulla piazza e scorse subito la macchina rossa che aspettava a lato del marciapiede. Si avvicinò, mentre una vampata di rossore le coloriva il viso.
Baci e saluti. E poi finalmente via: strade e autostrade inghiottite dal piccolo bolide, risate, progetti, ancora chilometri macinati verso la mèta.
Il campeggio di Luino era affollato. La macchina fu rapidamente scaricata: le tende e tutto il resto giacquero a terra nelle piazzole assegnate. L’opera di montaggio richiese un tempo incalcolabile per quattro inesperti come loro e ci volle la consulenza di un gigantesco olandese, pratico di tubi e tiranti. Luca e Laura disponevano di una canadese militare grigio-verde, così minuscola che scompariva in mezzo a tante tende a più vani, con terrazza verandata, dai colori vivaci. Renzo e Giuliana montarono una tenda da mare, gialla e arancione, tra gli sguardi strabiliati dei campeggiatori. Qualcuno, con una certa dose di sfrontatezza, domandò se avrebbero dormito in piedi.
Nessuno di loro sì creò problemi per l’inadeguatezza di quelle temporanee dimore; l’amore e l'avventura riempivano ogni angolo dei loro pensieri.
I due giorni seguenti trascorsero tra gite, pastasciutte, risate. Laura si premurò di inviare una cartolina quando andarono in Svizzera a fare rifornimento di benzina e sigarette e poi telefonò a casa con le dita fredde. Quando il padre le chiese il numero dell’albergo, interruppe la linea con l’intento di far credere che fosse caduta. Il pensiero dei suoi, così inconsapevoli, le dette un brivido di malinconia. Scacciò con rabbia il pensiero fastidioso, fece inaridire i semi del dubbio, uscì sorridente dalla cabina telefonica incontro all’allegra brigata.
Il giorno dopo il cielo non prometteva niente di buono: una cappa di piombo, le nubi gravide di tempesta, l'aria immobile nonostante un’inquietudine impercettibile nei fremiti delle foglie. Anche Laura era inquieta, con l’animo pervaso di presagi inafferrabili, comunque decisamente deleteri per l’umore.
«Sei meteoropatica!» sentenziava Giuliana dall’alto dei suoi centoquarantacinque centimetri di statura, il cui sonno non era stato minimamente disturbato dalle dimensioni della tenda da mare, nella quale invece Renzo era costretto a fare di se stesso un pacco regalo senza fiocco. Luca si dava da fare con bistecche di dimensioni dinosauriche per sfamare la compagnia e condiva di allegria pasti pantagruelici. Almeno ci provava: l'area plumbea sulle loro teste sembrava un castigo divino e alle tre del pomeriggio cominciò a piovere. I villeggianti, per rompere la monotonia della giornata, si dispersero per paesi e villaggi in cerca di colore locale.
Nelle vicinanze, a fianco di un paesino noto solo ai compilatori di carte topografiche, dall’insignificante nome di Grantola, era montata una Festa dell’Unità più grande dell’intero paese. Solite effusioni di chi si trova, sparso per il mondo, a contatto con chi coltiva ideali comuni; soliti abbracci tra la bianca Lombardia e la rossa Toscana.
Più che rossi, i quattro villeggianti erano lividi dal freddo: la pioggia ormai aveva decisamente preso piede e cadeva fitta sugli stand; la terra riarsa, dopo aver tracannato avidamente i primi scrosci, non riceveva più e si formavano pozzanghere larghe e nere.
La situazione precipitò al ritorno al campeggio: la canadese militare, senza fondo, galleggiava sulle falde di stoffa insieme alle vettovaglie e ai pochi effetti personali, mentre un colpo di vento aveva abbattuto l’orgoglio della tenda marina che prima svettava tra le altre. A piedi nudi, tra il fango, ognuno raccolse le sue povere cose e cercò conforto nell’alluvionata Festa dell’Unità di Grantola.
I compagni si fecero in quattro per cercare una soluzione, parlando fitto fitto con Luca e Renzo, dandosi una voce per chiedere, mentre Laura e Giuliana si guardavano smarrite e pensavano a un domani da senzatetto. Era quella la splendida vacanza che avevano sognato? Scambiarono qualche parola con alcune donne dai grembiuli sporchi che evidentemente avevano lavorato allo stand della ristorazione. Ma il dialetto era pressoché incomprensibile e la conversazione durò poco.
L’unico modo per uscire dalla situazione parve un pernottamento in un casolare, in un luogo non ben precisato, dove qualcuno accompagnò i derelitti con sollecitudine affettuosa, con una punta di intento consolatorio.
Era già buio quando il bolide rosso arrancò su per una strada sterrata e si fermò nei pressi di una distesa d’erba alta un metro, dove tre individui, avvisati dal rumore dei motori, aspettavano in compagnia di un cane enorme, dal pelo bianco, trattenuto a stento da un assalto all’ultimo sangue. Fecero strada verso il casolare mezzo diroccato, e sulla soglia della porta si dileguarono.
I quattro si addentrarono nel luogo fitto di tenebre; la ricerca di interruttori risultò vana. Le torce che provvidenzialmente si erano portati, li guidarono verso stanze vuote, dove luridi materassi gettati a terra sembrano violentare la nudità delle camere. In confronto, Robinson Crusoe diventava un vacanziere spensierato.
Dormirono tutti vestiti, abbracciati per cercare un po’ di calore. Il tempo della passione pareva lontano mille miglia. Luca cercava di consolare Laura dicendo che tutto sommato era un’esperienza divertente trovarsi in una situazione così carica di imprevisti. Laura non rispondeva, batteva i denti e basta. “Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria...”, come disse il Poeta, e Laura non poté fare a meno di spargere qualche lacrima sul materasso già abbastanza umido, pensando con un rigurgito di nostalgia alla piccola canadese militare.
Nel bel mezzo della notte, un sobbalzo: degli spari affettarono il silenzio come coltelli affilati. Fu il panico: Renzo comparve sulla soglia della camera con gli occhi spiritati e la cuffia da bagno (contro il freddo, come spiegò poi), seguito da Giuliana con indosso tutto quello che aveva potuto trovare, compreso un paio di calze di nylon intorno al collo. Si consumarono le ore in mille ipotesi. Col cuore in gola tutti si aspettavano un finale da tregenda e quando l’alba spuntò, ancora grigia e stentata, quattro nasi si affacciarono alle imposte delle finestre. Tutto taceva nella nebbiolina ovattata. Il sole di Livorno era all’altro capo del mondo, così come le vie conosciute, le spiagge limpide, la beceraggine di sempre.
Di acqua per lavarsi, neanche l’ombra. Appiattiti lungo i muri, uscirono all’aperto; si imbatterono subito negli sguardi diffidenti dei tre individui e nelle froge dilatate della belva canina del giorno prima.
«Come si chiama?» fece Giuliana con tono accattivante nel tentativo di stabilire un qualsiasi rapporto umano.
«Spaccaossi » fu la lapidaria risposta.
Tutti e quattro fecero prudentemente un passo indietro. Poche parole di saluto e poi finalmente verso il mondo civile.
Alla Festa dell’Unità qualche volenteroso compagno rimasto la notte per la sorveglianza penzolava ancora la testa tra veglia e sonno. Riconobbero uno che li aveva guidati nella spedizione. Dove li aveva portati? Cos’erano quegli spari notturni? Al tono allarmato rispose con una gran risata: «Ma sono contrabbandieri, no?»
Il casolare si trovava proprio sulla linea di confine, con le finestre in Svizzera e la porta il Italia ed era il punto di riferimento di frequenti scorribande notturne in cui gli spari erano la finta risposta dei doganieri a una vera spedizione di contrabbandieri, con i quali dopo poco avrebbero diviso gli utili.
Laura pensò di sfuggita ai suoi che probabilmente stavano ancora dormendo placidi, pensandola in qualche confortante pensione svizzera. Non sarebbe mai più tornata in quell’orrendo casolare, nemmeno da parlarne. Invece ci tornò, eccome: un’altra notte con tanto di spari e batticuore.
Il quinto giorno i compagni di Grantola li ospitarono tutti in una casa vera, con mobili veri, per una cena di saluto. Finalmente distesi, potevano godersi la conversazione, disquisire sulla fantapolitica, rispondere distribuendo sorrisi e battute, sforzandosi di capire le espressioni idiomatiche e cercando a loro volta di farsi comprendere.
A qualcuno venne in mente di accompagnare gli ospiti a vedere l’ottava meraviglia: una di quelle comuni di extraparlamentari che tanto andavano di moda negli anni Settanta, sorta su un terreno poco distante.
Di nuovo tutti in macchina, in un certo senso felici di fare una nuova esperienza. D’un tratto l’auto si fermò nel buio pesto e dal finestrino aperto entrò la canna di un mitra. Era il benvenuto nella comunità. Scortati da vari comunardi in completo assetto di guerra, videro di tutto: prefabbricati adibiti a mensa, a scuola, a laboratori, famiglie allargate, campi di lavoro, centinaia di matrjoske, migliaia di bottiglie di vodka.
Annegarono nell’alcool l’ultimo briciolo di coscienza.
Tutto questo mi fu raccontato dopo alcuni anni, durante un incontro con amici, nel momento in cui si cede ai ricordi e si raccontano aneddoti. Mi interessavo ai particolari e partecipavo con umorismo alle disavventure che sentivo narrare, sgranavo gli occhi per la meraviglia, la suspance aveva invaso ogni anfratto della mia attenzione. Mi ricordavo vagamente di aver vissuto una volta una vacanza avventurosa, ma non riuscivo a mettere a fuoco le immagini, i contorni sfumati di persone e cose erano riposte in un cantuccio della mia memoria. Peccato non poter condividere con gli altri il piacere di raccontare! Mi abbandonai all’ascolto, ma mi sentivo come chi ha fame e non riesce a portare il cucchiaio alla bocca. La luce era soffusa, le risate composte, i toni moderati, io scivolavo, scivolavo... dove? dove? in quali meandri mi portavano le parole? Le tre del mattino. Tra poco più di un’ora Laura si sarebbe alzata... Luca… Luino…, la tenda militare…
A proposito, Laura sono io.
INTANTO IO M'AVVIO
Grazie a un parto prematuro e precipitoso, Luigi Tempestini si tolse subito il pensiero di nascere. Sarà per i tempi stretti richiesti dall'evento, sarà per ereditarietà e fattori genetici, fatto sta che tutta la sua esistenza divenne una corsa contro il tempo in tutte le sue manifestazioni vitali.
Da bambino, ancora alle scuole elementari, tanto per anticiparsi, scavalcava la finestra a piano terra della sua classe e si avviava a casa senza attendere il suono della campanella. Recidivo, in prima magistrale l'Ispettore ministeriale, chiamato dal Preside a esaminare il caso, decretò: «Espulso da tutte le scuole del Regno d'Italia» tra il giubilo dell'interessato, piuttosto refrattario a sottostare a qualsiasi tipo di disciplina, e lo sgomento familiare, specialmente se si considerava il fatto che la figlia femmina era buona, brava e intelligente, ma era una femmina, quindi completamente superfluo che studiasse.
Quando andava a dormire, Luigi si sfilava la maglia o le maniche della camicia così che la mattina se le rimetteva come si presentavano, cioè a rovescio. Un giorno quindi era vestito da diritto e un giorno da rovescio. Lo stesso succedeva per il pigiama. Tanto per non sprecare tempo prezioso in bagattelle come quella di stare a rivoltare capi d'abbigliamento.
A tavola ingoiava, senza quasi masticare, quello che aveva nel piatto, alzandosi con il boccone in bocca per andare a vestirsi e correre, con un'ora di anticipo, all'appuntamento con gli amici.
«Dove vai a quest'ora?» gli chiedeva la madre.
«Tra un po' mi aspettano Titino e Silvano. Intanto io m'avvio» e correva senza ascoltare la sua voce accorata: «Sarai la mia rovina, mascalzone delinquente! Mi farai morire giovane!»
E glielo ripeteva tutte le volte che le riferivano di averlo visto andare in bicicletta sulla spalletta dei Fossi, tra lo sbalordimento e gli avvertimenti preoccupati della gente.
Si aggregava volentieri a ragazzi più grandi di lui, mostrando la stessa sicurezza e aggressività, ma, essendo più piccolo fisicamente, non sempre riusciva nelle sfide: nel tentativo di saltare una fogna a cielo aperto vi cadde dentro e, in pieno febbraio, fu costretto a spogliarsi, lavare gli indumenti in mare, metterli ad asciugare vicino a un fuoco improvvisato sulla spiaggia. Il risultato fu ovviamente un malanno con quaranta di febbre.
«Questa è un'influenza coi fiocchi» osservò il medico dopo averlo visitato. Lo stato comatoso di Luigi non era comunque dovuto solo alla malattia, ma anche alla scarica di scappellotti ricevuti perché le scarpe nuove di cuoio, messe accanto alla fiamma, si erano ridotte di tre misure.
Un'altra volta, in una prova di abilità che consisteva nell'aggirare mucchi di asfalto lungo il bordo di una strada di in costruzione, per fare prima montò con la bicicletta sopra il primo, che si sgretolò, mandandolo a gambe all'aria: altri scappellotti dagli stradini, che allora badavano meno al sottile con i ragazzi birichini, e qualche 'carezza' dal padre per aver ridotto gli abiti in uno stato degno solo della spazzatura: «Fallo un'altra volta e ti spello vivo!»
A volte facevano un gioco piuttosto crudele: legavano le code dei gatti ai portoni e poi bussavano, spiando la sorpresa di chi, nell'aprire, si trovava di fronte un felino non propriamente a suo agio e piuttosto arrabbiato. Luigi, per risparmiare tempo e godersi due spettacoli in una volta sola, legava direttamente le code di due gatti con una corda e poi collegava il collo di ciascun gatto a due portoni diversi, e la storia finiva tra miagolii angosciosi e imprecazioni dei proprietari che, aprendo, si trovavano davanti bestiole semimorte dallo spavento.
Non per nulla lo chiamavano “il terrore di piazza Mazzini”.
Come profetizzato, la madre morì, forse di crepacuore, quando lui aveva dieci anni, per cui in famiglia ci fu un certo rivoluzionamento. Il padre comprò una casa in comproprietà con una cognata, pure vedova con una figlia, Lillina. Oltre a occuparsi di un negozio di verdure, la cognata avrebbe dovuto mandare avanti la casa insieme a Lillina; la sorella di Luigi, maggiore di due anni, avrebbe dato una mano; il padre, tranviere di professione, avrebbe gestito il negozio di olio e vino (che aveva da sempre) nel tempo libero dai turni di lavoro, aiutato in parte dalla figlia, in parte dal figlio, che aveva l'incarico di fare le consegne a domicilio.
Per sbrigare prima le sue faccende, Luigi trovò la maniera di fissare alla bicicletta un robusto contenitore che gli consentiva di trasportare un carico maggiore.
«Stai attento,» diceva il padre «se caschi rompi tutto, e io ti rovino. »
E difatti non sempre i fiaschi finivano tra le mani dei clienti, ma in frantumi per la strada, causando una rimessa economica e la promessa punizione corporea. Ha sempre raccontato che il padre teneva la cinghia dei pantaloni a portata di mano e la usava diverse volte al giorno. È vero che i metodi educativi di quei tempi erano tutt'altro che montessoriani, ma bisogna anche comprendere la disperazione di quell'uomo che, oltre a essere stato colpito dalla disgrazia della moglie, ora si trovava tra capo e collo anche la disgrazia del figlio, che non si sapeva per quanto sarebbe ancora campato e che cosa sarebbe stato capace di combinare in vita sua. Tutti lo davano come caso disperato.
A sedici anni, per essere in anticipo sui tempi, cominciò a diventare calvo e da questo punto di vista assunse a diciotto l'aspetto di un quarantenne. A diciannove fu chiamato alle armi, data la guerra in atto, e fu subito ricoverato in un ospedale in osservazione psichiatrica.
Finito il conflitto, cercò di sfondare in diversi campi: come attore a Cinecittà, come funambolo in una compagnia di girovaghi, come baritono. Quest'ultima attività, che era forse quella che più gli si confaceva, benché prevedesse lunghi e faticosi anni di studi, fu troncata il giorno stesso del debutto, una sera d'inverno fredda e piovosa, quando, non vedendo arrivare il tenore che doveva cantare con lui, dopo due minuti di ritardo andò personalmente a casa sua a chiamarlo buscandosi una laringite che gli rovinò per sempre la resistenza a esibizioni canore decentemente lunghe. Dovette contentarsi di cantatine leggere e di lavoretti saltuari per qualche anno, finché non andò a fare il tranviere al posto del padre.
Ebbe anche il coraggio di trovarsi una moglie, senz'altro in odore di santità per tutte le sofferenze, non fisiche ma psicologiche, che ha dovuto sopportare per adeguarsi alla sua vita eternamente in lotta contro il tempo. In viaggio di nozze, per fare più in fretta a prepararsi la mattina successiva, mise il tubetto del dentifricio nel taschino della giacca: non si sa come, si ruppe, e la moglie, che non si aspettava certo una collocazione così anomala per un oggetto da toilette che di solito sta in valigia, ne subì le conseguenze con reiterati rimproveri: «Sei una sbadata! Ma dove ce l'hai la testa? Ora quanto tempo ci vuole per portare la giacca in tintoria e comprare un altro dentifricio?»
Non è l'atteggiamento tipico di un sessantenne con trent'anni di matrimonio sulle spalle, invece che di uno sposino novello, tutto moine e paroline dolci?
«Pazienza, stai tranquillo, se è colpa mia mi dispiace. Ma che fretta c'è? Non abbiamo mica orari stabiliti!» A lei sembrava un discorso sensato, ma non a lui che non ha mai conosciuto il significato della parola 'ragionevolezza'.
La domenica a quei tempi, soprattutto d'inverno, di solito si passava il pomeriggio al cinema. L'apertura era alle due e mezzo, il che comportava pranzo alle undici e preparativi per l'uscita verso l'una. Comunque verso mezzogiorno o poco più, Luigi annunciava: «Intanto io m'avvio.»
La moglie lo raggiungeva da sola, più tardi, alla colonnina della piazza centrale per la scelta del film. All'una e mezzo erano davanti al cinema in attesa dell'apertura. Alle cinque erano di nuovo a casa: fine della domenica.
D'estate andavano a fare un giro in Vespa. Appena Luigi sentiva la pressione della mano della moglie sul sellino posteriore, movimento che le donne facevano per sedersi all’amazzone, partiva lasciandola regolarmente a terra. È successo qualche volta anche che sentendola salire sul sedile posteriore della macchina, lui sia partito e lei abbia fatto qualche metro con un piede dentro e l'altro di corsa sul marciapiede.
Avendo una casetta in costruzione in campagna, Luigi, che ne seguiva i lavori con la moglie, si raccomandava: «Alle due fatti trovare pronta, se no si fa tardi.»
E la moglie si faceva trovare pronta ma, stanca di sentirselo ripetere ogni giorno, dato che si sa che l'ansia è ansiogena, una volta, presa da disperazione, gli lasciò un biglietto sul tavolo di cucina: Mi sono avviata al capolinea dell'autobus. Mi trovi già pronta sulla strada.
A Luigi è capitato, come conseguenza delle sue intemperanze temporali, di doversi fare una protesi dentaria, non già perché avesse i denti malati, anzi, ci schiacciava le noci, quanto perché il continuo digrignarli nervosamente li aveva consunti fino alla polpa.
«Ne valeva la pena?» commentò la moglie che invece aveva avuto problemi più gravi, nonostante la sua naturale tranquillità.
Detto così, potrebbe sembrare che Luigi sia una persona negativa, invece è molto generoso, altruista e disponibile, per cui, quando la moglie si accinge a pulire la casa a fondo, lui è subito in prima linea e offre la propria collaborazione:
«Le serrande te le pulisco io.»
Alla moglie vengono subito i sudori freddi perché sa che deve far da manovale:
«Sciacqua il cencio, porgimi la spugna, cambia l'acqua, dammi un panno pulito! »
Agli ordini! Tutto viene eseguito in tempo record e Luigi esce tranquillo e sereno (si fa per dire). La moglie riprende la scala, il secchio, gli stracci, il detersivo e completa il lavoro nella maniera che avrebbe voluto.
Attualmente Luigi è in pensione e la sua giornata comincia con sveglia spontanea alle cinque del mattino, anche d'inverno, quando i galli hanno ancora davanti a sé due ore buone di sonno e per la strada si possono incontrare solo i lupi. Meno male che non intona il Nessun dorma per la buona pace con il vicinato.
Alle cinque e mezzo si avvia a prendere il giornale aspettando l'apertura dell'edicola a mezzo chilometro di distanza, perché quella all'angolo della strada apre un quarto d'ora più tardi (ore sei).
«A volte anche alle sei e sette, sei e otto» ha precisato una volta che gli è stata contestata tanta fretta.
Torna a casa, legge il giornale, se si può chiamare lettura, lo passa alla moglie e intanto si infila la giacchetta e si mette in attesa in piedi accanto a lei con le braccia incrociate. La moglie guarda i titoli della cronaca e i necrologi e lo passa subito al marito che, alle sei e quarantacinque lo va a depositare nella cassetta postale della figlia, la quale lo ritira all'una, quando torna dal lavoro. Non avrebbe sua madre il diritto di leggerselo in santa pace?
Alle otto e mezza va sul portone per aspettare il postino, brontolando se ritarda. Se riceve una bolletta, non la fa nemmeno freddare: corre immediatamente alle Poste per pagarla. Unico caso, almeno in Italia.
Alle nove e venti si siede in attesa del pranzo (!) tamburellando con le dita sul tavolino.
«Non è ancora pronto? » chiede se l'attesa si protrae per più di cinque minuti.
Mangiando pochissimo, conclude il pasto dopo dieci minuti scarsi, quindi va a bere un caffè al Circolo affollato di gente che sta facendo colazione con brioche e cappuccino.
Torna a casa e si appisola sul divano per un'oretta, dopo di che comincia a girare in bicicletta per la città. Quasi sempre è informato sugli incidenti che avvengono sul territorio urbano perché, pare impossibile, si trova sempre sul posto giusto al momento giusto.
Verso le cinque cena e, visto il divario con il pranzo, è tutto sommato l'ora giusta. Passa il resto della serata alla televisione torturando il telecomando fino alle sette e quaranta. A quell'ora la sua giornata si conclude: dopo aver ascoltato i titoli del telegiornale di RAITRE, va a letto. Meno male non intona il 'Silenzio' perché non sa suonare la tromba.
Alla stessa ora la moglie comincia invece a respirare un'aria vitale, concedendosi qualche ora di televisione senza cambiare canale. Il telecomando ringrazia sentitamente.
Si può chiamare vita, questa? Quali opportunità esistono di intrecciare un qualsiasi rapporto sociale? Non si possono scambiare inviti perché, se è vero che il galateo impone che l'ospite si adegui agli orari di chi lo invita, è ovvio che non ci sono possibilità di mediazione. Non si possono fare visite di cortesia perché rischi di trovare i padroni di casa a tavola, creando reciproca difficoltà anche perché ti viene spontaneo esprimere moti di meraviglia. Non si possono nemmeno prendere appuntamenti fuori perché, all'idea dell'anticipo con il quale il signor Luigi fa le cose, pensando ai tempi delle sue attese, sorge un inevitabile senso di colpa. Si può solo salutare con 'buongiorno' o 'buonasera' e scambiare due parole, se quello non comincia a guardare l'orologio con evidente agitazione.
È risaputo che i proverbi rappresentano la saggezza popolare, anche se talvolta, analizzati doverosamente, rivelano indubbie contraddizioni. Quale pensate che Luigi abbia fatto proprio, per giustificare i suoi comportamenti: 'Chi va piano va sano e va lontano' o chi 'Chi prima arriva prima alloggia'? 'Vivi e lascia vivere’ o 'Morto io, accidenti a chi resta'? 'L'unione fa la forza' o 'Chi fa da sé fa per tre’? 'Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te’ o 'Il primo prossimo è se stesso?' Neppure la Sacre Scritture, ha rispettato!
Ora, parafrasando il famoso corsivista di un noto quotidiano a proposito di un personaggio politico, si può affermare che “poiché nascere non è obbligatorio” Luigi Tempestini “ci poteva anche risparmiare il suo lieto evento”. Possiamo aggiungere: per ragioni di ereditarietà, meno male ha avuto un solo figlio!
LA PALANCA
Guido Badalasso, classe 1894, faceva il tranviere da due anni. Non era stato sfortunato: a tanti era capitato di tornare dalla guerra e di non trovare neppure uno straccio di lavoro. Ora però si trovava sulle spalle un sacco di problemi: una vecchia madre malata e quattro figli ancora ragazzi, senza contare quel risentimento ai polmoni che la tubercolosi gli aveva lasciato senza chiedere neppure il permesso. E con i polmoni non c’era tanto da scherzare!
Una mattina di febbraio gelida come il marmo di una tomba, prese servizio sulla linea che, passando dal viale Regina Margherita, andava alla stazione.
Il collega che smontava lo rincuorò: «Fa un freddo che leva il pelo!”.
Ecco, proprio quello che ci voleva: avrebbe dovuto sopportare lo spiffero gelato che entrava dalle aperture laterali della vettura e che arrivava fino nelle ossa, nonostante i fogli di giornale messi ad arte tra la maglia e la divisa a protezione dal freddo.
Rimuginava sulla sua salute e per qualche attimo dimenticò il pensiero di come poteva pagare il debito contratto per alcuni interventi urgenti nella topaia dove viveva. Si issò a bordo con un malessere addosso che non riusciva neppure a definire con chiarezza.
Meno male che tutto filò liscio: bastava un niente perché un ispettore dal viso grifagno ti appioppasse una multa. Per questo controllava spesso l’orologio, un Moeris da taschino con su scritto Soc. An. Tramways di Livorno che la SATL, l’azienda tranviaria di proprietà belga, aveva regalato a tutti i conduttori perché rispettassero gli orari e che faceva la sua bella figura con la catena d’ottone che penzolava sul panciotto di stoffa grigio piombo.
A un tratto, all’altezza di piazza Mazzini, vide davanti a sé qualcosa che luccicava. Di colpo tutti i sensi si fecero vigili. Forse era un’allucinazione, forse la fantasia gli giocava brutti scherzi, forse era un raggio di sole che batteva sulla rotaia…
Si sporse in avanti ed ebbe la conferma: si trattava di una palanca, una moneta d’oro grande e così grandi non c’erano che le cento lire!
Per una cifra del genere era disposto a infrangere tutte le regole del mondo: frenò e scese per raccogliere quel dono inaspettato. Ma era ormai troppo tardi.
Trovò la palanca poco distante, schizzata via dopo essere stata irrimediabilmente piegata dalla pesante ruota del tram.
Mentre, chino, rincorreva brandelli di sogni infranti sulla rotaia insieme alla moneta, si vide sovrastare da un’ombra. Era un ometto elegante con la cimice del Partito fascista all’occhiello, un passeggero che aveva notato sul tram.
«La tessera!» intimò quello senza tanti complimenti.
«Non ce l’ho» ammise Guido con un tuffo al cuore.
«Sapete che distruggere il denaro è oltraggio al regime? »
«Io non volevo distruggere niente, ho frenato, l’avete sentito, ma non ce l’ho fatta.»
I passeggeri erano scesi e osservavano incuriositi.
«Potrei accompagnarvi in questura.»
«Non ho fatto niente di male. Perché avrei dovuto distruggerla?»
«Avreste voluto prenderla, eh? Anche questo è un reato.»
«No, no, per carità!» Guido mentiva sapendo di mentire, mentre si asciugava il sudore sulla fronte. «L’avrei consegnata. Poi, se nessuno l’avesse cercata…»
«Questa volta la passate liscia. Se per caso però vi trovassi di nuovo sulla mia strada, e senza tessera, faremmo i conti. Al Duce!» disse salutando romanamente, poi allungò la mano e intascò la moneta. «La consegnerò io a chi di dovere» sentenziò.
Guido pensò… anzi, non pensò niente, non ci riusciva. Arrivò a fine turno, andò a casa e si mise a letto con la febbre. Fu una notte di incubi: mille volte si vide mentre uccideva quell’ometto che si era intascata la sua palanca. La paga di quanti giorni? Sette, dieci? Finita nelle tasche di un fascista! E che non gli venisse a raccontare che non se l’era tenuta per sé!
“Spero che gli ci vogliano tutte di medicine” pensò la mattina dopo. Lui sapeva bene cosa significava veder sparire i soldi nel cassetto del farmacista.
Guido non si era mai occupato di politica, sostenitore del principio “vivi e lascia vivere”, quindi non si poteva rimproverare niente, meno che mai di aver agito contro il fascismo. Tuttavia, rimuginando sull’accaduto, decise che non gli piaceva per niente quella maniera di aggredire la gente e di intimorirla. A qualcuno che glielo aveva fatto presente, nel passato, aveva risposto che se uno si comportava bene, non doveva avere timori di sorta. Ora però aveva bisogno di raccontare quel fatto a qualcuno, aveva bisogno di parlare con altre persone di tanti episodi accaduti ai quali non aveva dato o non avevo voluto dare peso.
Ci pensò una settimana, alla fine decise di andare a raccontare il fatto a un suo vecchio amico socialista.