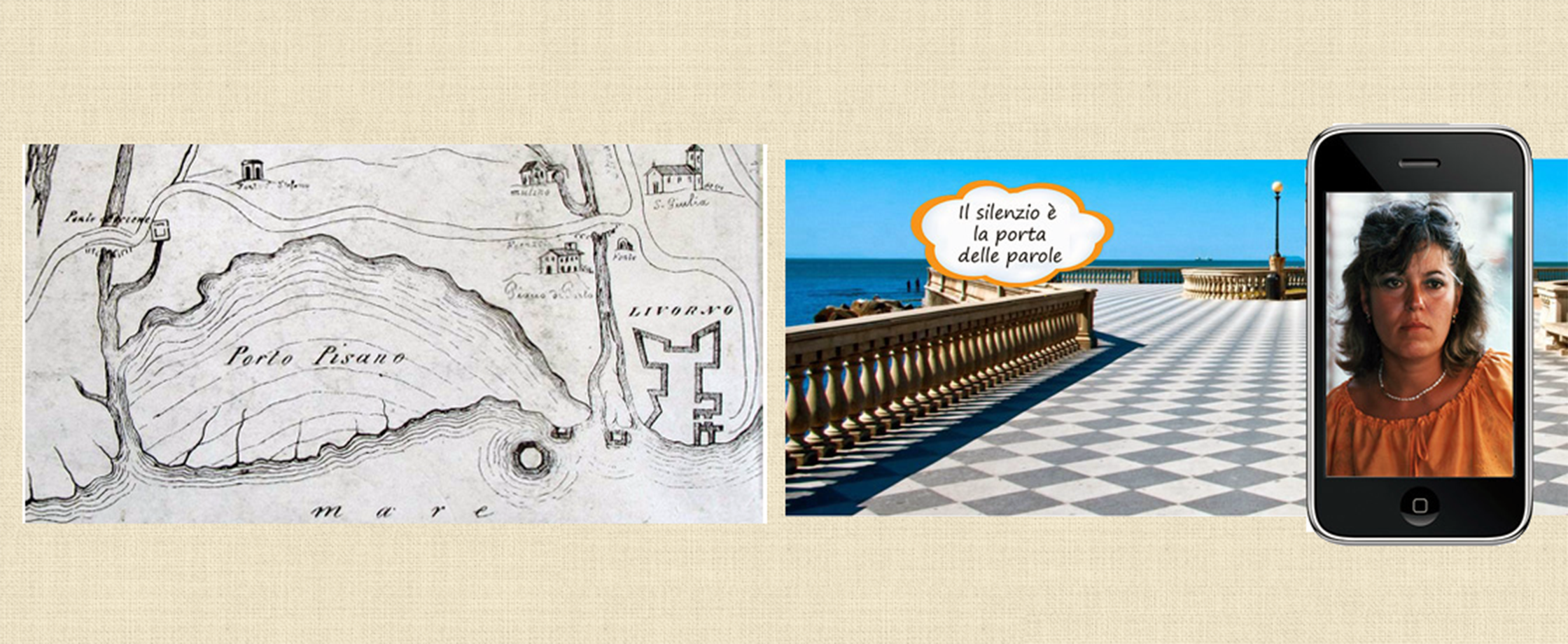
ALLA RISCOPERTA DEL VERNACOLO LIVORNESE
INTRODUZIONE
Il fenomeno linguistico più appariscente delle parlate toscane è la cosiddetta “gorgia” (particolare intonazione o inflessione di voce o di pronuncia), cioè l’aspirazione delle consonanti occlusive intervocaliche P, T, K. Questo fenomeno, che è per lo più attribuito al mantenimento di un’abitudine orale degli Etruschi, anche se non tutti sono d’accordo con tale tesi (per es. G. Rohlfs) perché pare risalente a non oltre il Cinquecento, scompare a mano a mano che si procede verso la Toscana occidentale. Pisa e Livorno infatti non aspirano, omettono addirittura la consonante occlusiva intervocalica, ma limitatamente al suono K, mentre le altre vengono pronunciate regolarmente; se mai la pronuncia caratteristica di certe consonanti assume aspetti diversi, ma di questo parleremo in seguito. […]
LA LETTERATURA VERNACOLA LIVORNESE
Purtroppo non esistono documenti scritti del vernacolo livornese fino al XVIII secolo, e si tratta di qualche canzonetta giocosa o satirica, per lo più riferita a fatti di cronaca popolare; pochissimi i poeti (G.B. Fagiuoli, N. Falcini, un Anonimo) che hanno lasciato composizioni di una certa consistenza e non tutte attendibili. […]
LA FONETICA E MORFOLOGIA
E veniamo alle caratteristiche concrete del vernacolo livornese, come esso era parlato nella “Venezia” dello scorso secolo. Per quanto riguarda la fonetica, sottolineiamo queste caratteristiche, molte delle quali messe in evidenza anche dal glottologo Francesco Papanti:
- l'aferesi delle vocali in principio di parola ('un per non, ‘nvece per invece, ‘tumobile per automobile, ‘sciogamano al posto di asciugamano, limosina per elemosina)
- la sincope della c intervocalica (musi’a per musica, cari’o per carico)
- l'apocope dell’ultima sillaba dell’infinito (morì per morire, finì per finire)
- i troncamenti per sincope (eramo per eravamo, andorno o andonno per andarono, tremoto per terremoto) o per aferesi (rivà per arrivare, tavia per tuttavia)
- le metatesi (drento per dentro, stranuto per starnuto, tronitore per tornitore, strapolto per trasporto, treciòlo per cetriolo, grillanda per ghirlanda, bertelle per bretelle, rispiarmo per risparmio, direto per dietro, sbinonno per bisnonno)
- l'assimilazione della r della desinenza dell'infinito nei verbi con pronome enclitico (amammi per amarmi, vedetti per vederti, sentivvi per sertirvi) o con la particella pronominale ne enclitica (lascianne per lasciarne), eccetto che per la seconda coniugazione (prendine per prenderne, vendine per venderne)
- la geminazione della b in alcune parole (robba per roba, subbito per subito, abborto per aborto)
- l’epentesi della b dopo la m intervocalica in alcune parole (cambera per camera, stomba’o per stomaco, camberieri per cameriere, co'ombero per cocomero)
- l'uso della doppia alterazione, soprattutto nella campagna (bimbottetto, robbettaccia, ragazzottetta, bruntoncello, bruttetto, bruttotto, ma anche poi'inino = più che pochino)
[…]
PRESTITI LINGUISTICI
Per quanto riguarda i prestiti, erano un tempo in uso molte parole di varia derivazione, naturalmente storpiate per adattarle alla pronuncia più naturale del livornese. Ecco alcuni esempi: dall’inglese (gli Inglesi ebbero molti contatti con Livorno per motivi commerciali) abbiamo “gis” (da just) che significava “ammodo” (una ragazzina propio gis), “miccimènne” (da midshipman) che significava “guardiamarina”. Numerosi termini passarono nel linguaggio popolare quando, finita la seconda guerra mondiale, il comando militare alleato del Mediterraneo si trasferì da Napoli a Livorno: “lescò” (da let’s go) = vattene, sparisci; “pòlice” o “pòllice” (da police) = poliziotto; “smòchinge” = fumare; “emme pi” (iniziali di Militar Police); “comò” (da come on) = avvicinati; “carabuse” o “calabusce” (da calaboose) = prigione. […]
LATINISMI
Abbastanza numerosi erano anche i latinismi, soprattutto nelle campagne vicine. A parte il verbo ire, con l’uso anche del participio passato “ito”, ci sembra significativa l’espressione “sortì de’ pupilli” che significa “diventare grande, adulto” con chiaro riferimento alla parola latina “pupilla” = bambola, così che nell’insieme significa “uscire dall’età dei giochi”; o il nome di un’erba commestibile chiamata “sprargine” che si può ricollegare a “supra arginem” perché appunto si raccoglie lungo gli argini; "respice fine" (respice finem) preceduto dal verbo fare significa fare piazza pulita, soprattutto di cibi (feciano respice fine). […]
STORPIATURE E IPERCORRETTISMI
Molte storpiature non seguono una regola fissa. Citiamo qui alcuni esempi, solo una minima parte rispetto alla realtà:
bafore = vapore
capumilla = camomilla
catafere = cadavere
frustato = frustrato
Consapevole di commettere molti errori, il popolano livornese qualche volta mostra la volontà di correggersi, con l'uso di ipercorrettismi, basandosi sulle regole dell’analogia o per assonanza con termini o suoni noti:
Ameleto = Amleto
astemico = astemio
bacule = baule
[…]
GLOSSARIO
Premettiamo che il segno tipografico dell’apostrofo corrisponde nel corpo di una parola alla omissione della c o della ch, a fine parola indica un’apocope, a inizio di parola l’elisione di c, ch, n, i, u. Un asterisco premesso alla parola significa che essa non compare sul dizionario della lingua italiana, oppure vi compare con significati diversi (il lavoro di riscontro è stato effettuato sul dizionario Devoto-Oli). La ricerca riguarda vari settori della vita e ogni settore comprende un estratto del glossario, delle frasi idiomatiche, dei proverbi e, dove è stato possibile reperire materiale, anche di stornelli, canzoncine, filastrocche che fanno parte della tradizione livornese senza essere necessariamente in vernacolo. Per quanto riguarda i proverbi, essi sono stati inseriti nell’area di riferimento anche se è ovvio che assumono un significato metaforico a seconda del contesto. La stessa cosa vale per gli stornelli.